Un poeta destinato a restare
di Pietro Gibellini
Mi giova partire dalla riconsiderazione del volume di atti della giornata di studi dedicata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia agli esiti di scrittura di Luciano Cecchinel al Centro Culturale Candiani di Mestre (volume uscito nel 2012 col titolo La parola scoscesa. Poesia e paesaggi di Luciano Cecchinel, con l’esemplare cura di Alessandro Scarsella, per i tipi di Marsilio).
Devo dire che in questo Paese che va come va, in questa Università che sta come ognun sa, consola sfogliare un volume che raccoglie e concreta i frutti di un convegno stimolante e innovativo: non “fiera delle vanità” ma occasione di approfondimenti acuti e di originali acquisizioni, su un poeta in dialetto e in italiano di solida tempra, destinato a restare: poiché la voce dei poeti si oppone, e talvolta vince, l’inesorabile estinzione delle lingue perdenti. Un bell’esempio di metodo e di serietà per i giovani studiosi del Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia classico-medievale, che sostenne con calore l’idea, lanciata in primis dal generoso amico Alessandro Scarsella, di dedicare una giornata di studio alla poesia di Luciano Cecchinel, scandagliato da ricercatori affermati e giovani, accademici e militanti, tutti accomunati dal requisito del rigore e della passione.

Un bell’antidoto, anche, alla confusione di una Scuola dottorale che ingloba tutte le discipline, dall’economia alla linguistica, dalle scienze alla letteratura (sic), sollecitando i dottorandi a illustrare con un poster, a mo’ di imbonitori, il loro progetto di ricerca, e invitando i docenti a tenere lezione in inglese. Nel nostro dottorato, s’intende, hanno più spazio altre lingue: il greco, il latino e l’italiano, compresa la sua sterminata ricchezza di dialetti. La letteratura italiana, osservò Gianfranco Contini, è la sola nella quale il dialetto faccia «visceralmente» corpo con la lingua: teorema da cui discende, come corollario, il fatto che togliere dal corpus i testi scritti in dialetto, nutriti di idiomi locali o venati di tinte vernacolari, comporterebbe una mutilazione forse mortale: come immaginare l’antologia delle nostre lettere senza Ruzante e Basile, senza Porta e Belli, senza Marin e Loi? Pasolini è ancora tale senza i versi in friulano? E Zanzotto senza Filò? Cosa resta all’affresco della prosa verghiana se leviamo l’intonaco della sua sintassi siciliana? E il lucente tappeto del pastiche (e del pasticciaccio) di Gadda, manterrebbe i suoi fili e colori senza i nodi lessicali e i groppi babelici che lo assemblano?
A tal proposito, ci si chiede spesso come possiamo salvare i dialetti (in realtà nessuno di noi può salvarli e, in fondo, non è competenza nostra). Ma la funzione dei poeti è in questo senso assai importante. Non siamo riusciti a salvare il latino ma il fatto che sia stato usato da Catullo, Virgilio e da altri grandi poeti della romanità, nonché dai riti di Santa Madre Chiesa, fa sì che ce ne occupiamo ancora fruttuosamente. Io, devo dire, non sapevo cosa fosse il tràgol jért ma grazie al poeta Cecchinel sono riuscito a sapere che era l’«erta strada da strascino».
Da un lato, quindi, salvare il dialetto è impossibile. Le lingue muoiono, e muoiono assomigliando al loro assassino, vale a dire assimilandosi sempre più alla lingua che le uccide, come diceva in un magnifico saggio Benvenuto Aronne Terracini: la lingua celtica o quella paleoveneta sono morte assomigliando al latino, il dialetto muore assomigliando all’italiano, che dal canto suo sta morendo assomigliando all’inglese.

Siamo di fronte a un fenomeno che ci sovrasta, ma d’altra parte la poesia riesce a salvare da un livello sincronico di lingua un mondo umano: tutto un universo di valori può sopravvivere attraverso questo sortilegio della parola.
Cecchinel ha detto più volte che la sua lingua indigena è quella di linea paterna, soprattutto da parte di nonna, e rileggendo Mistieròi constatiamo che Zanzotto, dopo aver rievocato e invocato le nonne, si dichiara contento di aver tenuto vivo il loro mondo. Ecco, proprio su questa previsione dell’estinzione dei dialetti, che è irrimediabile, si apre un confortante spiraglio: attraverso la poesia il dialetto trasmette un sistema di valori che è una ricchezza, un vero e proprio patrimonio che rivitalizza la nostra memoria e la nostra sostanza interiore.
Zanzotto, dicevo. Al convegno Andrea non poté presenziare, ma non volle far mancare il suo testo: segno di stima e di affetto per un discepolo e, al tempo stesso, originale erede. Non mi fa velo la riconoscenza verso Cecchinel, che mi accompagnò a Pieve di Soligo a vedere, per l’ultima volta, il poeta che conoscevo da sempre: e fra i titoli che progettava per la sua ultima raccolta, e di cui si discorse quel pomeriggio a casa sua, finì poi per scegliere quello che anche a me era parso il più felice: Conglomerati (ero reduce dalla visita all’incantevole Molinet de la Croda, e Andrea parlava di strati rocciosi perduti nell’abisso del tempo). Dico vedere, ché quanto a sentirlo comunicammo telefonicamente, per interposta Rai, nella trasmissione legata al suo compleanno: che avremmo dovuto festeggiare pochi giorni dopo a Pieve e che si trasformò in una commemorazione.

Luciano Cecchinel ha scelto la sola via che un poeta degno di tal nome è tenuto a seguire: quella dell’adesione alla vita, propria e altrui, e dell’ascolto della voce che gli “ditta dentro”; egli parla un idioma che esige di esser inteso e rispettato. Zanzotto sente morire giorno per giorno il dialetto sulla punta della sua stessa lingua, come sente morire l’italiano di Leopardi, retrocesso a dialektòs nel dilagante inglese degli economisti, non di Shakespeare (ne discussero Zanzotto e Loi con me e Orelli, in un lontano incontro alla televisione svizzera, per l’imminente uscita di Filò). Ma quel «vècio parlar» gli serve per regredire nella memoria e nella propria psiche individuale e collettiva, dal petèl per i lattanti ai Mistieròi scomparsi, dalla beltà di un paesaggio da ecloga virgiliana alle rune paleovenete e al prebabelico linguaggio di Eva. L’affondo di Zanzotto cala soprattutto nel paesaggio esterno e interiore, difesa di un universo civile e sensato che nella favella nativa vede il faro di una ricerca conoscitiva; la sua resistenza ideale – di quella storica contro i nazifascisti non si dimenticò mai – si esplica contro il mare della propria nevrosi e della nuova barbarie tecnologica che distrugge il verde dei boschi e l’azzurro della mente.
In Cecchinel la spinta di fondo mi pare piuttosto etica e corale: il suo dolore viene, oltre che dal mistero della nevrosi, dalla partecipazione quasi ombelicale alle problematiche, spesso assai sofferte, di tutta una comunità, e solo più di recente dall’immedicabile ferita sofferta nel più caro affetto familiare. Ma, prima dell’immane tragedia, lungi dal ripiegarsi esclusivamente sul proprio io, egli rievoca il mondo che nulla ha di idillico, dà lingua a ‘una gente che tace’; una lingua (della sua gente e sua), ‘tutta tagli’, scheggiata e petrosa come il paesaggio che rappresenta, denudato da ogni velatura idillica o nostalgica.

Nella sua opera egli muove certo da un sentire personale ma per confluire in istanze complessive. Ciò avviene in Al tràgol jért, in cui l’idillio dell’infanzia/adolescenza viene presto a inerire al travaglio di portata antropologica dell’estinzione di tutta una cultura; così come in Lungo la traccia, in cui la saga familiare italoamericana si risolve nel tema complessivo dell’emigrazione; infine, quasi con evidenza di intenti, per i drammi legati alla lotta di liberazione con i suoi acri risvolti di guerra civile, in Perché ancora e ne Le voci di Bardiaga.
E anche quando sprofondi dentro ‘la gola dell’abisso’, la dominante di Cecchinel è piuttosto di natura morale: lascia trasparire l’eredità di una seria formazione cattolica coniugata ad un sincero e mai esibito impegno democratico, senza però che i valori politici e sociali possano tacitare le esigenze imperiose della coscienza. La traumatica scoperta dei cadaveri di giustiziati, creduti dell’una e poi rivelatisi dell’altra parte, è assai indicativa al riguardo (mi riferisco alla raccolta in italiano Le voci di Bardiaga).
Nel suo processo di ispirazione sembra che in fondo egli tenda a celare l’«io egotico» sotto un «io collettivo», senza ad ogni modo completamente riuscirci. E si potrebbe del resto fare poesia senza un margine di narcisismo? Certamente no. Alla fine, è peraltro sempre una rappresentazione prevalentemente comunitaria ad acquisire vigore sulla scia di stravolgimenti socioeconomici o catastrofi della storia.
Solo più avanti la scrittura di Cecchinel si è fatta più intimista, come si può evincere dal confronto tra la già citata sua prima opera in dialetto Al tràgol jért e la più recente Sanjut de stran. Quest’ultima, se mantiene un’autonomia di natura denotativa nella misura in cui si radica al collasso rapidamente consumatosi di una cultura secolarmente statica ma pregna di sedimenti vitali, rimanda di passo in passo a qualcos’altro, in una congerie di significazioni personalmente connotate che vengono a costituire un assetto di comunicazione parallelo. Per cui, rispetto alla prima produzione in dialetto, denotativamente legata attraverso vari elementi pragmatico-referenziali a quella cultura che aveva ancora vigore, sembra di poter più propriamente parlare di idioletto.

E, consolidando questo indirizzo, di recente, come già accennato, i suoi testi si sono fatti più propriamente intimisti. Come esplicitato dal poeta infatti, a datare dal 2000, anno in cui si verificò la ricaduta definitiva nella malattia della figlia Silvia cui fece seguito la sua scomparsa l’anno seguente, si determinò una cesura irreparabile nella sua vita e nel suo percorso di scrittura, con un’inibizione alla via della poesia, perché da allora ogni possibile ispirazione veniva immediatamente sopraffatta dal pensiero di quella tragedia. E se il pensiero dominante non poteva che essere quello legato alla figlia sfortunata, egli non poteva certo allora ridurla, malata e poi perduta, a soggetto letterario. Talché egli ha dichiarato che verso la scrittura aveva ad un certo punto maturato un vero e proprio rigetto.
Anche sulla base di questo sentire da “viscere tranciate”, ha avuto corso molto tempo dopo In silenzioso affiorare, un poemetto che si può definire affettivo-familiare: nelle sue righe, tra varie epifanie dell’amore coniugale, piomba repentino il dolore più grande. Che, a quanto dichiarato da Cecchinel, ha trovato peraltro nel tempo sofferta e ossessiva sedimentazione in una corposa silloge di inediti.
Considerando la traiettoria finora compiuta, trobar clus potrebbe sembrare quello del nostro poeta: non per cifrate oscurità, ma per la scelta di suoni aspri e insieme drammaticamente sonori che distingue decisamente il dettato di Cecchinel da quello del suo auctor, febbrilmente sperimentale, arduo talvolta e spesso franto, ma condotto sulla falsariga di una cercata levità, di una aspirazione al canto, seppur minacciato in permanenza dall’afasìa.
Altra è la voce, ritrosa e timida ma insieme tenace di Cecchinel (la colse bene, fra gli altri, Matteo Vercesi, cui devo il primo incontro con la persona riservata e discreta di Luciano): ruvida come scorza legnosa ma percorsa da sottostanti linfe di ipersensibile sottigliezza. La sua poesia preserva una lingua che sembra morire dall’ingiuria del tempo, facendosi scudo contro l’incuria degli uomini, contro l’inumanità dei tempi.
Pietro Gibellini
©riproduzione riservata

Lingue dal profilo di brace
di Matteo Vercesi
Riconosciuto come una delle voci più alte della poesia italiana contemporanea, Luciano Cecchinel esprime nel canone del presente un proprio grado di esclusiva singolarità, essendo l’unico autore vivente ad essere approdato ad esiti artistici assoluti nell’utilizzo di registri linguistici differenziali: il dialetto e l’italiano. Nessuno è infatti riuscito ad operare nei due codici un lavoro di scavo tanto pervasivo e convincente e a stabilire un siffatto ferreo controllo formale della materia, definendo un campo semantico allargato, nel binomio idioletto-lingua, che appare permeato di complesse stratificazioni. L’attenzione della critica, negli anni, ha giustamente evidenziato come al centro della sua poesia vi sia il valore primario dell’esperienza. Una parola lontanissima da derive astrattiste e da incorporee sovrastrutture, fedele al proprio contesto di appartenenza (Revine Lago e le Prealpi trevigiane); poesia a dialogo con alcuni cantori della letteratura occidentale (Whitman, Esenin, Frost, Mandel’štam, tanto per citarne alcuni), lambita da echi filosofici (riconosciuti, tra gli altri, da prestigiosi esponenti di quell’ambito) e al contempo umilmente “offerta” a chi della voce è stato privato: emarginati, depressi, eroi dimenticati della nostra storia nazionale, riaffiorati dal cono d’ombra grazie ad una scrittura lirica che diviene ricostruzione di tracciati umani interrotti o sommersi, innervata da una visione pessimistica e sofferta che non rinuncia però alla tensione etica.

Ripercorrendo il sentiero definito da alcune delle sue opere più significative, dall’esordio avvenuto nel 1988 con Al tràgol jért. L’erta strada da strascino (edizione rivista ed ampliata dieci anni a seguire per la scheiwilleriana All’Insegna del Pesce d’Oro, con postfazione di Andrea Zanzotto), sino all’ultima raccolta intitolata Da un tempo di profumi e gelo (postfazione di Rolando Damiani, LietoColle, 2016), emerge il profilo di un poeta viandante che ha saputo annodare con magistrale perizia ed una forza evocativa senza eguali i fili del proprio cammino esistenziale ed artistico a destini collettivi che rivelano ferite ancora aperte lungo il processo di costruzione identitaria del nostro Paese, e che è stato in grado – penso soprattutto ai suoi due ultimi volumi – di universalizzare la propria dimensione familiare, rendendola esemplare narrazione di resistenza ai drammi della vita.
Se Al tràgol jért attesta la fine della civiltà rurale e il progressivo scollamento da una dimensione di natura, mai idealizzata ma piuttosto vissuta nello strazio della “fatica contadina” (aperta però all’incanto e alla fascinazione di un paesaggio arcano e misterioso, con cifre di incontaminata beltà), Lungo la traccia (Einaudi, 2005) segna invece, sotto l’egida tematica dell’emigrazione negli Stati Uniti, un viaggio di riscoperta delle proprie origini. Il volume trilingue (italiano, dialetto, francese in traduzione) Perché ancora / Pourquoi encore (con note di Claude Mouchard e Martin Rueff, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea del Vittoriese, 2005) e Le voci di Bardiaga (Il Ponte del Sale, 2008) rappresentano una riflessione – lirica e storico-politica al contempo – sulla Resistenza, vicenda che ancor oggi fa avvertire la propria onda propagatrice in seno alla società italiana, oscillante fra spinte utopiche e divisioni. Sanjut de stran (prefazione di Cesare Segre, Marsilio, 2011) incarna un viaggio sotterraneo votato a divinità infere e costellato da ossessioni e follia, mentre In silenzioso affiorare (prefazione di Silvio Ramat, con sei acquerelli di Danila Casagrande, Tipoteca Italiana, 2015), canzoniere domestico intimo, doloroso e tenero, e Da un tempo di profumi e gelo, perimetrano invece una galassia privata fitta di chiaroscuri.
Cecchinel, durante la cerimonia per il conferimento del Premio Biagio Marin, svoltasi a Grado il 24 gennaio 2015, ha affermato: «quando si dice che la poesia è l’arte di dire non dicendo o, per converso, che è l’arte di non dire dicendo, non si additano solo gli effetti del mestiere secondo una tecnica di sostituzione o sottrazione di segni o sintagmi, ma anche gli effetti di ciò che si sente in modo oscuro, appunto più o meno irrazionale». La sua, come ogni autentica scrittura, si confronta inevitabilmente con una parte di ignoto, pur nell’attestazione di un dolore psichico evidentissimo, dai tratti materici sfibranti. Le sue due lingue pulsano come braci dal fondo oscuro di una sostanza segreta, che è quell’Altro inattingibile a cui la parola consente, perlomeno, di approssimarsi:
Nei tuoi occhi in scoperto fulgore
si abbattono tempeste,
traboccano acque,
sussultano lampi.
E nella tua sostanza segreta
brulicano fabbriche,
si sconvolgono magmi,
pulsano braci.
Poi i tuoi capelli
mosse fronde resinose,
il tuo cuore tana impazzita,
i tuoi singhiozzi palpiti di viole.
«Finnegans» intende dedicare a questo poeta appartato, umile ma tenace, un’antologia di testi, di stralci critici, di testimonianze e di fotografie. Un’occasione di rilettura della sua opera che sicuramente offrirà nuove chiavi di decifrazione a chi vorrà addentrarsi nella selva dolente dei suoi libri.
Matteo Vercesi
©riproduzione riservata

Il silenzioso affiorare di un uomo e di un poeta
Conversazione con Luciano Cecchinel
a cura di Diego Lorenzi e Giuseppe Stefanel
Alcuni mesi fa siamo andati a Revine Lago per incontrare il poeta Luciano Cecchinel, autore di numerose opere di poesia, in buona parte in dialetto. L’accoglienza è stata molto cordiale, la conversazione è durata circa tre ore, intervallata solo da una leggera degustazione di prodotti di casa, scivolando via con leggerezza.
L’approccio è stato del tutto confidenziale, d’altronde ci conosciamo da diversi anni, durante i quali ci siamo spesso incontrati e confrontati sul terreno accidentato della natura umana e della poesia, convergendo spesso verso le colline del solighese, per intercettare il flusso poetico denso e universale di Andrea Zanzotto, suo intimo amico e confidente.
Non c’è stato bisogno di alcun preambolo, né di qualche premessa introduttiva, perché Cecchinel ha aperto la conversazione raccontando un po’ di aneddoti che riguardano soprattutto il mondo letterario, facendo poi gradatamente rotta verso i territori della sua poesia e della sua passione umana, civile, spirituale e artistica, per condividere alcune riflessioni per poter poi dire, con orgoglio intellettuale: “finalmente un poeta è entrato nella nostra vita”.
Da allora ci siamo rivisti altre volte, cercando di dare un senso compiuto alla nostra conversazione e rivedendone alcune parti. Quella che vi presentiamo è, dunque, una lunga quanto appassionata condivisione, scaturita da una profonda e personale confluenza umana e letteraria, che vi trasmettiamo integralmente nella speranza che possiate conoscere e apprezzare un poeta autentico e un uomo sinceramente appassionato della vita come pochi altri. Anche nella disgrazia e nel dolore.
(Lorenzi) Luciano, ci puoi raccontare i tuoi primi passi in ambito poetico e letterario?
Quando ero giovane mi dilettavo a leggere delle poesie, anche se non sono mai stato un grande tecnico della scrittura, cioè uno che si fosse dato da subito una struttura in senso retorico: sentivo la tensione a scrivere per fermare dei modi di sentire che confinavano con l’ineffabile. Provare a mettere qualcosa per iscritto era come innescare la traccia per ritrovarli. Ricordo di aver scritto da adolescente, ai tempi del ginnasio, tra il ’61 e il ’63, un testo in francese, e uno in italiano: il primo lo ho ritrovato, il secondo no.
Venne quindi l’università, di cui dopo quattro mesi abbandonai la frequenza seguendola a distanza solo per dare gli esami e per le pratiche di segreteria perché mio padre a causa di un gravissimo infarto rimase per lungo tempo segregato in ospedale fra la vita e la morte e poi in buona percentuale invalidato ed io, quale fratello maggiore, con la madre assente per l’assistenza, dovetti seguire i miei fratelli. L’anno seguente intrapresi l’insegnamento – lo praticai per circa due anni – per sostenere la situazione economica della famiglia temporaneamente deficitaria a causa della lunga degenza di mio padre.
A ventitrè anni mi trovai risucchiato nell’agone politico e fui eletto sindaco del mio comune. Fu un periodo molto intenso quanto stressante, in cui l’attività amministrativa fu totalmente assorbente dopo l’orario di lavoro… la letteratura divenne così un lusso, tanto di rado potevo concedermela.
Comunque anche durante gli anni del servizio militare scrissi qualcosa: ricordo un abbozzo di poesia in italiano che poi ripresi e ultimai in dialetto.
Ma fu dalla fine del 1975, anno dell’uscita dall’esperienza politico-amministrativa, che cominciai a scrivere: nel doloroso ripiegamento che ne era seguito risultò anche una forma di linimento interiore, direi, a suo modo, una terapia.
(L) Quali erano i tuoi riferimenti poetici?
Non potevano essere che quelli degli anni del liceo, Dante, Petrarca, Foscolo, Leopardi… anche se la letteratura che mi ha coinvolto di più è stata quella francese, studiata al ginnasio e in seguito quella russa, certo anche sotto la suggestione del fatto che il mio bisnonno Gaetano Gerardini era stato in Russia in varie riprese per ben ventisette anni.
Devo dire in tutta confidenza che studiavo poco. Ero decisamente refrattario all’ambiente del liceo classico, tendenzialmente chic e in modi generalmente artefatti; sfortunatamente poi trovai un insegnante di italiano che mi fece detestare le sue ore di lezione e di riflesso anche la materia.
Comunque, se studiavo poco, leggevo molto. Giocando a calcio – a quanto sento dire ancor oggi, assai bene – guadagnavo con i premi-partita parecchi soldi che destinavo all’acquisto di libri, soprattutto della BUR, generalmente però, come si può ancor oggi evincere dal catalogo, di narrativa e teatro.

(Stefanel) Bene. Altri due incisi, il primo che riguarda il servizio militare, dove l’hai fatto e in quale corpo.
L’ho fatto nell’artiglieria da campagna. In realtà il mio primo inquadramento prevedeva che fossi o granatiere o dell’artiglieria da montagna ma mi fu cambiato il corpo in ordine al fatto che, essendo sindaco del mio comune, avevo diritto ad un avvicinamento: feci l’addestramento a Casale Monferrato, poi fui destinato a un paese vicino a Udine ma subito dopo alla caserma “Cadorin” di Treviso, per finire “aggregato” alla caserma “Gotti” di Vittorio Veneto. Per il fitto incrocio di incombenze – guardie notturne e rientri tardivi per riunioni serali – rimediai un forte esaurimento e ricordo che dovetti sottopormi a una sostenuta cura a base di iniezioni. Alla fine il periodo “meno peggiore” risultò essere stato per me proprio quello del C.A.R., generalmente considerato il più duro.
(S) Cos’altro ti senti di dire, con gli occhi di oggi, della tua esperienza politica?
Premesso che sono nato e sono stato educato in un ambiente cattolico (alla stessa scuola elementare pubblica ho avuto come insegnanti delle Suore della Misericordia), ho militato per sei anni nella sinistra DC, avendo come punti di riferimento gli onorevoli Francesco Fabbri e Tina Anselmi.
Devo dire che, se alcuni del mio partito mi osteggiavano, fui sostenuto in consiglio comunale anche dalla minoranza comunista e socialista, che, per inciso, non mi ha mai votato contro in cinque anni: si astenne una sola volta sul bilancio, probabilmente perché psicologicamente pressata da un folto pubblico di parte.
Ma certo poi la campagna politica dell’opposizione complessiva, peraltro non condotta dagli esponenti che avevo in consiglio comunale, fu, più che impietosamente, sconciamente demagogica.
Mi è inevitabile constatare che, se ero un democristiano di sinistra, mi trovo ora, senza essermi spostato, ancora più a sinistra: certo, in un periodo di frequenti trasformismi come l’attuale si sono spostati molti altri. Per cui mi trovo spesso a dover constatare che chi mi ha criticato da sinistra ora lo fa da destra; ma non è più un fatto paradossale, è per molti anzi consuetudine far calzare alle idee – guarda caso quelle al momento in auge – i propri personalismi. Certo si può contare sulla carente o superficiale memoria storica dei nostri giorni. Ma è tristemente eloquente come l’esercizio parolaio della politica tenti di camuffare i trasbordi politici. E il fatto che si dica che sono tramontate le ideologie non è ragione sufficiente per certi salti di quaglia: sotto le ideologie ci stavano ben riconoscibili valori e rinnegare quelli che sono stati i propri valori di fondo significa negare anche la propria identità, fatto che non può non essere mentalmente presente a chi in modo disinvolto cambia radicalmente posizioni politiche. Penso che di ciò ci sia consapevolezza, anche in termini di psicanalisi del linguaggio, in un esponente politico delle mie parti che si è alcuni anni or sono autoqualificato dall’interno di una compagine di centrodestra “un progressista di centrodestra”. Come dire che copriva da solo la destra, la sinistra e, per automatica combinazione, il centro. Ricordando che trent’anni fa, nel fulgore politico e culturale della “sinistra ideologica”, egli entrò nelle liste gestite da un PCI non ancora convenientemente “rivistosi”, vien da pensare che si considerasse allora “un conservatore di centrosinistra”.
A parole in qualche modo il conto si può sempre far tornare.
A questo punto si può solo interrogarsi pessimisticamente sulla struttura interiore dell’uomo ed evitare il rapporto dialogico con tali soggetti: discorrere con loro sarebbe come andarsi a cercare un’inevitabile occasione di scontro. È infatti evidente che sarebbe, se non impossibile, assai arduo dire, anche per sola constatazione, queste cose, senza rischiare di risultare offensivi.

(L) Sappiamo che hai iniziato da amministratore l’esperienza della cooperazione agricola unitamente a dei compaesani che erano certo più vecchi di te anche di due generazioni. La tua/vostra attività è stata anche un atto di resistenza a favore del territorio. E come hai poi vissuto il boom economico e il suo sviluppo?
Parto dalla coda della domanda.
Certo non ero sociologicamente preparato ad un cambiamento così rapido ed ho vissuto drammaticamente le problematiche che si imponevano nel mio paese a seguito dell’imperioso imporsi di un’economia determinata da nuovi poli economici. Mi trovai a dover fare i conti con un’emigrazione di massa: gli agricoltori non venivano pagati per quanto lavoravano e subivano la sempre più forte attrazione dell’industria, peraltro nella nostra zona assai carente. Intuivo che c’era una grande forza esterna che si faceva preminente corrodendo la vita di tutto un ambiente. Attecchivano in modo sempre più diffuso esigenze di status sociale e di tenore di vita superiori; pochi erano ancora disposti a vivere come prima, perché vedevano degli esempi diversi anche all’interno della propria comunità. Non c’era più una società che, pur subalterna, rimaneva vasta, per cui la stragrande maggioranza si sentiva un po’ alla pari, come era stato in un lunghissimo periodo in cui la liquidità, scarsa e quindi non fondamentale, era ottenuta periodicamente sulla vendita del latte o di qualche capo di bestiame o pollame e delle uova. Allora si viveva in buona misura di autoconsumo: si produceva quasi tutto in casa, anche le scarpe, gli scarpét o le dàlmede (rispettivamente delle calzature di panno suolate a gomma e di legno per la stalla) e, con la lavorazione domestica della lana, la maggior parte del vestiario. Le specializzazioni avevano reciprocità di livello familiare e per quelle più particolari aveva spesso luogo un umile interscambio. Questa temperie faceva sì che nessuno si sentisse particolarmente esposto o ai margini.
Il lavoro, pur se faticoso, era a volte considerato anche passatempo, specie da parte dei giovani della comunità che si prestavano ad aiutare qualche contadino a rastrellare il fieno su un prato: c’era insomma il senso di una forma di vita unita sull’accettazione di un comune destino.
A partire dal verificarsi dei cambiamenti che tu richiami nella domanda il fenomeno della subalternità si è fatto molto più grave. Prima era, per così dire, ovattato, dato che di veramente abbienti ce n’erano pochissimi e quindi la maggior parte degli abitanti trovava il corrispettivo della propria situazione in molti altri, in una forma identitaria più che consolatoria. Col passar del tempo, essendosi parcellizzata la società in una miriade di filoni economico-sociali corrispondenti a specializzazioni del lavoro, il singolo ha trovato corrispettivo in un sempre minor numero di persone, con un progressivo acuirsi del senso di spaesamento, di smarrimento, di solitudine, talvolta ai limiti del tragico.
Già nel periodo della mia esperienza politico-amministrativa, era ben evidente che il vecchio sistema di vita si stava spappolando. E, come già detto, erano sempre in più a prendere la via dell’emigrazione.

(S) Da quel che ci pare di capire il fenomeno dell’emigrazione è stato nel tuo comune drammatico.
Purtroppo è stato proprio così. Revine-Lago, col suo territorio totalmente montano, era il comune che aveva il maggior numero di emigranti nella provincia di Treviso.
Nel 1970, su 2250 abitanti, circa 600 erano emigranti due terzi dei quali stagionali e un terzo iscritti all’Associazione Italiani Residenti all’Estero: soprattutto popolazione maschile.
Se poi andiamo indietro al periodo fascista, durante il quale l’emigrazione all’estero era interdetta, erano le donne ad andare nelle grandi città a fare le balie, per cui in certi quartieri di Milano balia equivaleva a revinese.
Questa emorragia aveva luogo ineluttabilmente ai miei tempi anche se l’appassionato responsabile dell’Ufficio di Collocamento, in un periodo che vedeva le liste di disoccupazione separate da comune a comune, non riusciva a far assumere un lavoratore di Revine-Lago a Vittorio o a Conegliano.
Ai fini di far rientrare molti degli emigranti fu necessario adoperarsi spasmodicamente per un incremento delle attività industriali. Questo portò certamente del benessere ma determinò, in un territorio di grande bellezza paesaggistica, delle compromissioni.
Con Zanzotto si accennava spesso alla distruzione dell’ambiente naturale, allo “sterminio dei campi” come lo definiva lui. Io gli dicevo che ai tempi della mia amministrazione pensavo che il nuovo sistema potesse convivere con quello precedente e non che lo avrebbe fatto fuori. Ma egli in fondo mi giustificò affermando, con esemplare onestà intellettuale: – E chi èrelo che podéa prevederlo –?
Ora, anche in relazione a quanto detto nella riflessione precedente, non si può chiedere lavoro e poi, una volta avutolo, assoluta integrità del paesaggio. Eppure, per proterva demagogia, si è assistito anche a questo.
(S) Certo il fenomeno dell’emigrazione fu correlato ad una grave crisi dell’attività agricola o più propriamente silvo-pastorale ma già il territorio coltivabile, certo paesaggisticamente suggestivo – il fondovalle è poi occupato da due laghi – è ridotto e ostico per la pratica dell’agricoltura…
Per quel che riguarda l’economia agricola, fu quello il periodo in cui la carne veniva sempre più sottopagata perché erano cominciate le importazioni dai Paesi dell’est europeo. Il bestiame là veniva acquistato, per vantaggiosissimi rapporti inerenti costi di produzione e valute, a prezzi molto bassi, determinando una concorrenza insostenibile per i contadini rimasti. A tanta derelizione ci siamo un po’ ribellati: eravamo partiti dall’idea di fare una malga sociale, ma presto i contadini realizzarono che era inutile andare avanti in questa prospettiva ( “il lavoro poi ce lo ruberebbero lo stesso”). Passò a questo punto l’idea di costituire una cooperativa per la vendita di prodotti agricoli; abbiamo trovato operatori del sindacato che ci hanno passato legislazioni e bozze di statuto. Abbiamo quindi riunito gli agricoltori di tre comuni, Revine-Lago, Tarzo e Cison di Valmarino, e pariteticamente costituito un’associazione di consumatori, in modo da poter far forza comune contro l’imposizione esterna dei prezzi. Da una parte i produttori disciplinavano il conferimento del bestiame, dall’altra i consumatori potevano vigilare attraverso dei rappresentanti sulla qualità della carne e sulla confezione dei pacchi in vendita, che aveva naturalmente luogo con tutti gli adempimenti sanitari previsti dalla legge.

(S) Questa esperienza di cooperazione intercomunale, che mi sembra ti sia stata molto a cuore, ha avuto lunga durata?
La cooperativa è iniziata nel ’74 ed è durata circa 20 anni; il luogo di confezione e vendita è ora sede dell’Associazione Alpini e le nostre celle, igienicamente ineccepibili, sono tornate buone per la loro cucina. Risultò ad ogni modo per noi assai confortante che, una volta chiusa la vecchia sede, un macellaio di Tarzo si prestasse ad aiutarci col suo macello privato. Così abbiamo tirato avanti in forma semi-pubblica per un’altra decina d’anni.
Sono entrato in quest’avventura politico-economica anche perché molti contadini erano miei amici e sono tra i pochi ad essere rimasti attaccati alla terra un po’ come dei soldati su un loro fronte, che certo si odia ma infine anche si ama perché è il lembo di terra in cui si è sofferto e si è lasciata parte della propria vita. Purtroppo i contadini ancor vivi si sono trovati abbastanza ‘spiantati’ e, per di più, da quegli effettivi difensori del territorio che sono stati, per paradossale ingiustizia anche misconosciuti da una genia di ‘agenti del futuro’ ben esperti di mercificazione, anche della parola.
(L) Quindi, lasciato il campo dell’amministrazione, hai continuato il tirocinio politico all’interno della cooperazione agraria…
Sì. Mentre ero impegnato nella costituzione dello spaccio intercomunale di prodotti agricoli di cui ho già detto, sono entrato in contatto per contiguità di intenti con una più vasta realtà, un consolidato gruppo operante per la costituzione di cooperative agricole, alcuni dei cui promotori avevo conosciuto all’interno del sindacato.
Il nucleo portante delle cooperative che costoro dirigevano, l’APAC (Associazione Produttori Agricoli e Consumatori) e l’APL (Associazione Produttori Latte) e con cui progressivamente venni io stesso ad operare, era rimasto parzialmente in piedi (dopo che il fallimento della seconda, dovuto a due contemporanei mancati pagamenti da bancarotte fraudolente, aveva compromesso anche la prima) come gruppo di riflessione e poi come cooperativa di servizi col nome di I.S.Co. (Impresa Servizi Coordinati). L’ente prese anche a pubblicare lavori di inchiesta e analisi sul mondo del sindacato e della scuola, correlati alla rivista politico-culturale “Confronto”, ai quali anch’io, in veste di redattore, a lungo collaborai.

(L) A proposito di editoria e di pubblicazioni, hai avuto difficoltà per cercare di pubblicare il primo libro di poesie?
No, giacché non ho “cercato”. La sua pubblicazione ha avuto luogo in naturale continuità con l’impegno politico-sociale sul cui alveo i miei testi erano per molteplici aspetti germinati ed è stata pertanto una specie di conferma di una scelta di vita.
Il materiale del mio primo possibile libro era giacente da anni e fu naturale per me, dopo le molte remore all’ostensione che il pubblicare comportava, farlo coi miei compagni di strada, alcuni dei quali da tempo in questo senso mi pressavano. Fra questi il professor Lucio Perosin, direttore della citata rivista e purtroppo recentemente deceduto, e il professor Aldo Bianchin, che, già segretario del SISM-CISL provinciale, poi dello IAL (Istituto Formazione Lavoratori) regionale e ora presidente degli europeisti del Veneto, ho riconosciuto da decenni come privilegiato punto di riferimento per il mio agire politico.
(L) Alla luce di questi trascorsi di impegno diretto, c’è stato in te anche un legame fra politica e poesia?
Sì, da un lato per una ragione di ordine generale, dall’altro per una particolare. Penso infatti sussista un legame tra politica e poesia nella misura in cui l’etica, su cui dovrebbe basarsi ogni impegno politico, è assimilabile, lo si voglia o meno, alla bellezza interiore, basilare anche per la ricerca e la ricezione poetica.
Per quanto poi più direttamente mi ha riguardato, la poesia è stata anche una forma di terapia in un periodo di buio interiore e chiusura, dovuto ad un percorso politico prematuro e in un periodo difficile e assai controverso, quanto caratterizzato spesso da un cieco scontro ideologico. Per ripassare nuovamente alla politica, di chi fossero soprattutto le responsabilità è a distanza di decenni ben visibile: un partito monolitico quanto sicuro di se stesso si è scoperto in regime di anacronismo almeno trentennale.
(L) … ancora un passo indietro, poco fa accennavi alla scrittura come terapia...
Sì, parlavo della funzione terapeutica della scrittura quale forma di linimento di un forte disagio interiore dopo le esperienze negative in veste di amministratore, legate soprattutto alle lotte politiche in seno al partito della DC e alle critiche strumentali di certa opposizione a livello sopracomunale, pragmaticamente – e direi, alla luce di quanto poi verificatosi, anche ottusamente – tetragona. Questo, per il carico di impegni e per disillusione in regime di ipersensibilità, mi portò a una grave usura interiore. Come già detto, era poi quello il periodo burrascoso del declino di un modello di società correlato alla civiltà contadina, con gravi rigurgiti di disoccupazione e emigrazione.

(L) La conservazione e la salvaguardia della natura, l’amicizia e la solidarietà tra esseri viventi, l’altruismo e la ricerca del bene comune, sono tutti valori che ti ha trasmesso tuo padre, anche attraverso degli esempi concreti come l’aver partecipato alla Resistenza, stimolando poi anche la tua passione politica. È così?
Prima di entrare nelle file della Resistenza, mio padre ha partecipato alla guerra in Jugoslavia, Albania e Grecia. È da dire che egli non avrebbe dovuto fare un giorno al fronte, perché era orfano di guerra e con un fratello con gravi handicap, ma l’apparato militare fascista lo spedì comunque in prima linea.
L’8 settembre del ’43 egli si trovava fortunatamente in Italia e quindi ha intrapreso la lotta di liberazione nella “Piave”, brigata autonoma di cui era stato uno dei fondatori e che agiva sotto la più vasta “Nanetti”… dovrei avere in una delle pile di libri sul tavolo una foto che lo ritrae mentre alla testa del battaglione Morandin entra in Conegliano liberata… stanno proprio in questi giorni procedendo alla ripubblicazione del libro dei suoi ricordi di vita partigiana.
In effetti la sua è stata una traiettoria pienamente civile: prima ha combattuto duramente, poi alla fine della guerra ha costituito con gli altri comandanti della brigata delle cooperative per dare del lavoro agli ex partigiani; ricordo che avevano avviato un’impresa edilizia con cui andavano a costruire case anche nella zona di Iesolo e Caorle, e poi un’azienda per la produzione di solfato di rame.
Per quanto riguarda la politica, in realtà egli non voleva prendervi parte attiva. È stato pressato da altri con finalità diverse dalle sue perché vi entrasse come loro comprimario e alla fine, per essere fedele ai suoi principi, vi è entrato con altri compagni in piena autonomia.
Ho constatato peraltro che nel tempo, sull’esperienza di vari rigurgiti politici, ha ammorbidito di molto, differentemente da me, le sue posizioni; abbiamo avuto anche parecchi scontri e ricordo che uno dei motivi del nostro teorico contendere verteva sulla percorribilità di certo agire politico che egli ammetteva dicendo che “se in politica non si fanno certe operazioni, gli altri ne fanno di molto peggiori”.

(L) Questo fa parte un po’ dei consueti contrasti tra padre e figlio, ma toglici una curiosità, come mai con tutti i valori, gli ideali, le utopie dell’epoca, non hai abbracciato il comunismo? Sono state le tue delle scelte motivate dalla fede religiosa, dalla tradizione, dalla famiglia?
Sì, in buona misura è stato così: come hai anticipato in chiave di domanda, sono stati fattori preminenti l’educazione religiosa e una famiglia esposta politicamente. Devo però dire che fu drammatico sostenere il confronto con la montante opposizione marxista.
Da molti suoi affiliati anche chi nell’esercizio politico viveva ragioni socialmente analoghe ma non la stessa prospettiva finale – mi ricorre qui alla memoria la formula ingiustamente irrisa delle “convergenze parallele” – doveva subire critiche e angherie, come operasse un’indebita invasione di campo. Ed era poi effettivamente più “produttivo” attaccare la parte eticamente migliore del partito rispetto a quella in questo senso, per non dire screditata, meno accreditata.
Così ci si trovava all’interno del partito in uno scontro senza quartiere con la destra dorotea per essere poi osteggiati dalla sinistra ufficiale per il fatto stesso di entrare in quello che essa riteneva esclusivo suo campo d’azione. Il massimo che si poteva ottenere era un sorrisetto di comprensione di una propria ingenuità o di una donchisciottesca velleità. Questa situazione esiziale la ho trovata ben delineata nel recente romanzo-documento di Nicola De Cilia Uno scandalo bianco.
Ulcerato da attanaglianti dilemmi, feci parecchi viaggi conoscitivi oltre cortina, tenendo spesso, per la pericolosità della sua perdita, la mano sulla tasca del passaporto, e, oltre a masticare anche in quel senso amari riscontri, dovetti appurare che in Italia era difficile raccontare quanto rilevato, per cui a un certo punto desistetti dal farlo.
Ma dopo la caduta del muro di Berlino, molte ipocrisie e, purtroppo, anche grandi e iterati crimini causati dai regimi comunisti, sono venuti allo scoperto.
Ho capito che la mia scelta, progressivamente confermata pur nell’usura di assillanti dubbi e di immeritati scherni, non era stata infondata e che non dovevo certo pentirmene. Se ho sempre cercato di essere coerente con un modello di società basato sulla giustizia sociale e sulla condivisione di valori etici e morali pur in situazioni e ambienti contraddittori e infausti, a distanza d’anni la storia mi ha dato ragione.
Ma sarà mai risarcito tutto questo? Forse non è risarcibile quando, se si bussa alle porte di molti di quei già strenui militanti, ci si trova, al di là di qualche encomiabile eccezione, a misurarsi con persone che non hanno fatto i conti con se stesse: semplicemente “non ricordano bene” il passato o, peggio, lo hanno totalmente rimosso. Zanzotto mi diceva che è come se alcuni riescano a farsi un buco nella mente.
Devo peraltro, a notificazione di pessimismo tardo-esistenziale, rimarcare cosa si è permessa la finanza dei paesi occidentali dopo il venir meno del contraltare del comunismo, a suo modo “calmieratore” a spese dei sottomessi ai suoi regimi.

(L) Tralasciamo i tuoi percorsi ideali e politici e addentriamoci invece nei territori della poesia e della letteratura. Quali sono state ad esempio le influenze rispetto alla scelta della poesia dialettale? Poi nel corso della conversazione approfondiremo altri aspetti del tuo essere poeta a tutto tondo.
Mah, si potrebbe pensare subito a Zanzotto, ma quando ho cominciato a scrivere, Filò non era ancora uscito. In realtà la mia prima vera influenza è venuta da Pasolini, con La meglio gioventù (una raccolta di poesie in dialetto friulano uscita nel 1954 n.d.r.), che mi ha confermato la possibilità di tentare la via della poesia con quel codice. Ma devo subito aggiungere che ho cominciato a scrivere in dialetto perché iniziavo a capire che il mondo che era stato il mio alveo di formazione e convivenza si stava sgretolando sotto il sempre più prepotente avanzare di nuovi assetti economici. In fondo, prendendo coscienza della sua rarefazione, io cercavo di fermarlo sulla carta e, in questo senso, non potevo pensare ad un linguaggio che non fosse quello del “mondo” che volevo contribuire a salvare, trattandosi oltre tutto di un tentativo di poesia, il cui significante, come per la pittura il colore e per la scultura il legno o la pietra, è appunto la parola.
Nel mio caso penso di poter dire che si è trattato della scelta di un mondo prima che di una lingua. E, lo ripeto, il fatto che di quel mondo il dialetto fosse un connotato – e, appunto, quello fondamentale in materia di poesia e quindi di espressione verbale – ne rendeva la scelta irrevocabile.
La questione potrebbe allora porsi in altri termini: perché la scelta di quel mondo?
Ecco. Per me l’ancoramento ad un mondo pervadente e trapassante, e per di più rarefatto, segnava anche una mia difficoltà a sperare nel domani. Certo mio rifiuto del presente, anche di ragione etica, innescava una direttrice di fuga che non andava verso il sogno, il futuro, ma verso il sogno mancato, relegato nel tempo trascorso: in fondo, paradossalmente, proiettavo quella che sarebbe dovuta essere un’aspettativa per il futuro nel passato, nella consapevolezza di un qualcosa di mancato e non più realizzabile.
Dunque una soluzione più che statica, nevroticamente regressiva.
(L) Ma il dialetto non ti sembra una scelta un po’ penalizzante, nel senso che confina in un recinto isolando da una maggior condivisione? Anche perché la scelta di comunicare attraverso un dialetto marginale arcaico restringe di molto la possibilità di un vero confronto letterario.
In effetti è penalizzante, anche perché il mio dialetto, arcaico, come tu ben dici, risulta, al di fuori dell’area pedemontana e bellunese, di difficile comprensione. Esso poi, legato prevalentemente a funzioni pragmatiche, è assai carente di termini astratti quanto di natura quasi assolutamente referenziale. Devo dire, al proposito, che un valido ricercatore linguistico e storico i cui genitori erano di Revine-Lago, Giovanni Tomasi, ha pubblicato un dizionario sulla parlata del paese che vale, per molteplici aspetti, da saggio antropologico: termini inerenti varie antiche tradizioni e il mondo del lavoro, in particolare quelli in uso tra contadini, muratori, falegnami, senza il suo impegno competente e meticoloso sarebbero andati irrimediabilmente perduti.
Per quanto concerne l’uso del dialetto in poesia, io penso che debba essere usato come lo si è imparato e poi seguito nella propria comunità e altresì che non può essere nella stessa misura dell’italiano lingua della sperimentazione.
Il codice dialettale, quale aspetto peculiarmente legato alla langue, ha una forza che si direbbe autonoma di conservarsi e trasmettersi nel tempo. Il fatto stesso di essere il significante di una cultura che ha avuto vigore millenario attraverso una continuità dai caratteri prevalentemente statici ha conferito a quel linguaggio un qualcosa di astorico e atemporale. Certo, dove si tratta di tentativo poetico, deve in qualche modo imporsi l’atto creativo ma vigerà comunque, assai più che in italiano, la tendenza a servire la langue, quale assetto stratificato e articolato; per dirla con una recente e felice dizione zanzottiana, “conglomerato”.


(L) L’uso del dialetto in poesia viene inoltre da alcuni considerato una scelta del tutto particolare anche a fini di possibilità di sperimentazione. Non rischia di essere visto come una scelta un po’ elitaria, anzi, a suo modo, quasi “aristocratica”?
Certo, più di un lettore o ascoltatore mi ha fatto questa osservazione, ben plausibile nel trovarsi di fronte a una forma espressiva con cui è difficile fare i conti, nel senso che restringe per difficoltà di comprensione il giro dei possibili fruitori e quindi dei potenziali valutatori, che vengono in questo caso a trovarsi alle prese col labirinto del codice prima che col labirintico “pasticcio” della poesia.
Per quanto concerne la sperimentabilità di percorsi fonico-ritmici inusitati che un codice “nuovo proprio perché antico” può consentire, questa è venuta per me di conserva, non certo come scelta primaria, che, come già detto, è stata quella di salvare un mondo e una civiltà in rarefazione anche attraverso il suo linguaggio. Ad ogni modo l’osservazione possibile di scelta linguistica aristocratica, può nel mio caso essere agevolmente ritorta contro chi la fa.
È da dire infatti che quando un’identità in crisi tende ad annullarsi in quella collettiva, sia pur essa trapassata, l’”io” diventa un “noi” e dal travaglio personale emerge il travaglio di tutta una cultura con i suoi referenti duri, scabri, a volte repellenti… dovrebbe darsi allora per amara ironia un’”aristocrazia del sudore, dei calli, del letame”, antipodi questi che non sembra proprio possibile far convivere col senso più invalso del termine élite, nemmeno in quello astruso delle figure retoriche.
(S) Ma, ad esempio, rispetto al dialetto del dopoguerra – il suo uso, a mio avviso, si lega molto alla manualità del fare – persistono delle corrispondenze?
Penso di sì, pur se relativamente, e mi riferisco a molti proverbi e i modi di dire.
Queste forme di pensiero hanno avuto strenua continuità, oltre che per la funzione di rinforzo discorsivo, proprio per la concretezza dei riferimenti da cui traevano origine. Ed è inevitabile che proprio questo aspetto, dopo aver determinato la loro fortuna, sia divenuto la causa prevalente dell’abbandono o della decadenza di molti di essi, conseguentemente allo sparire di molte delle funzioni pratiche o delle tradizioni cui erano legati.
Così lo scollamento fra l’assetto semantico e la sua referenzialità, che è poi lo scollamento fra la ritualità sentenziante e una primigenia concreta funzione, ha reso inutili perché totalmente incomprensibili molti proverbi e modi di dire. E’ altresì da notare che la consapevolezza di tale scollamento fa sì che altri proverbi vengano pronunciati “in translato” a testimonianza di certa sottile capacità mimetica di quello che resta della cultura contadina. Perdono essi comunque in questo caso un’altra delle caratteristiche che ne avevano determinato la fortuna: l’adescamento al ripetere attivato dal referente concreto, che rimane presente, ma in forma sfumata, solo nella mente dell’emittente che lo richiama col ricordo.
Questo vale per massime come al formài tra drio ’l scatol da quando non si fa più il formaggio in casa o in casera oppure per barca fondada no la à bisogno de sèssola da quando in una determinata località non si fabbricano più artigianalmente le barche; e altrettanto si può dire per se no l’é sopa l’é pan bagnà da quando i costumi culinari domestici hanno preso, con l’immersione nella nuova abbondanza, soluzioni meno frugali di quella del pane inzuppato nella minestra, ricetta recuperata peraltro in tempi recenti come revival folkloristico anche da qualche locale “chic”.
E lo stesso vale per modi di dire come l’é injazhà anca ’l mus in piazha da quando asini non se ne vedono passare o stazionare nelle piazze. E così per modi di dire come spale da mussa, cul fa na brinzhia o ndar dentro te ’l bartoèl (te ’l tamài) o no val basto né brena, da quando questi attrezzi non vengono più usati o lo vengono in cerchie affatto marginali. E altrettanto si deve dire per riferimenti a tradizioni desuete, ad esempio a quella del porzhèl de Sant’Antoni.

(S) A quanto dici, nel tuo tragitto scrittorio, hai cercato di agire nel rispetto al parlato locale. Pensi di esser riuscito in conveniente misura ad essere fedele ad un codice così connaturato alla fabertà?
Devo dire che ho sempre coltivato questo intento, che pure mi ha posto spesso di fronte a particolari problemi espressivi. E viepiù coll’andare del tempo. Quando ho cominciato a scrivere tutto era più facile quanto immediate erano le possibilità di verifica, dato che ero in piena sintonia con un mondo che era ancora vitale. Comunque ho visto e avuto conferma dalla gente del luogo – ad esempio da alcuni vecchi – che le mie ricerche in fatto di espressioni nel dialetto del luogo erano esatte. Un amico contadino, che ha letto i miei libri, ha detto di aver trovato tutti i termini perfetti. Ché poi – lo sosteneva anche Zanzotto – il mio dialetto, come dicevamo abbastanza arcaico, è molto duro e difficile e si avvicina particolarmente al bellunese. Ma come si sa, il dialetto è una realtà puntiforme, cambia anche da paese a paese: il mio ad esempio è già diverso da quello di Tarzo che si trova solo a tre chilometri e naturalmente molto di più da quello parlato a Conegliano, per non dire di Treviso: i dialetti lungo i secoli sono cambiati, si sono sensibilmente modificati subendo progressive contaminazioni da parte dei poli mercantilistici attraverso scambi commerciali sempre più intensi. Hanno finito così per sempre più levigarsi nelle loro asperità.
Devo dire a questo punto che si pone proprio anche il tema di una “fabertà” della trascrizione. Io ad esempio – ma ne ha avuti anche Zanzotto in Filò – ho un po’ di problemi nelle trascrizioni del dialetto, soprattutto con le doppie: per fare un esempio di difficoltosa risolvibilità, soprattutto per la trascrizione delle pronunce della “s”.
Molti autori seguono per la “s” aspra la resa con la doppia (“ss”) ma la comune pronuncia in italiano di tale doppio segno induce meccanicamente ad una conforme lettura; così, non pronunciandosi le doppie nella maggior parte dei dialetti veneti, sembra più opportuno usare la “s” singola per la pronuncia aspra e rendere di converso la sonora con la “s” con sopra un puntino, cosa tipograficamente non sempre agibile.
In altri casi, neppure io sono stato fedele nella resa grafico-fonetica, al basilare principio dell’unità del segno…
Faccio un esempio: per la “c” aspra, gutturale, in italiano si usa il “ch”, però i puristi metterebbero una “k” perché è il segno più semplice nella direzione del principio suesposto. Ma siccome un libro di poesie comporta anche un rispecchiamento di tipo narcisistico, proprio non riuscivo a rileggermi in un testo tempestato di “k”. Insomma, anch’io ho derogato, per un più gradevole rispecchiamento nei miei versi, a qualcuno dei canoni fondamentali della linguistica.
(L) Veniamo ora ad alcuni temi ricorrenti nelle tue composizioni poetiche: i ricordi e le tue radici culturali particolarmente legati alla natura; e poi la religione, il dolore.
La natura era già iscritta nel mio vivere quotidiano, nel lavoro, nelle frequentazioni degli amici, dei conoscenti, nelle epifanie del paesaggio che mi circondavano e nutrivano di bellezza. Ma io la natura non la vivevo come la vivono i lavoratori dei campi e della montagna e neppure come i turisti che frequentavano questi luoghi. I contadini e i montanari non possono quasi mai inquadrarla in senso idillico: il loro operare è scandito in base alle incombenze dei vari periodi stagionali col pensiero fisso a quali ore maggiormente sfruttare e a quali strumenti usare e, oltre che in senso settorialmente pragmatico, è spesso vissuto con sofferta preoccupazione.
Il turista e anche l’artista invece tendono a percepire la natura in senso totale ma prevalentemente oleografico, e quindi talvolta affatto superficiale. In altre parole vanno ben considerati i diversi approcci di chi ha con la natura un normale rapporto di lavoro e di chi la vive in termini di contemplazione.
L’ottica del turista o dell’artista tende generalmente a una visione d’assieme, che più facilmente si presta ad una fruizione di tenore idillico; così non è per il lavoratore di campagna o di montagna, che, come già detto, inquadra elemento per elemento in funzione dei suoi interventi di ordine pragmatico, e quindi distintamente collegati a valutazioni di modi, mezzi e carico di fatica. Ed è naturale a questo punto puntualizzare che se il lavoratore è meno permeabile ad una rappresentazione d’assieme e quindi meno sensibile ad inneschi idillici, il turista o l’uomo d’arte (ed è sintomatico a questo punto constatare che il termine “arte” per il lavoratore esiste come iperonimo a designare qualsiasi utensile possa risultare funzionale ad una bisogna contingente) non può cogliere il mondo naturale in tutta la sua verità, correndo il rischio di cadere nelle panie dell’oleografia.
Se per il senso artistico la natura si pone come cespite privilegiato di contemplazione – il luogo da cui attingere, come per un arcano sortilegio, l’ineffabile -, solo se si conosce anche il contatto con la natura anche attraverso il lavoro, essa potrà configurarsi in molte sue asperità, rimanendo sì il luogo dell’idillio ma, per così dire, “sotto condizione”. E se il contadino o il boscaiolo è sempre concentrato su aspetti pragmaticamente settoriali e il fruitore turista o artista solamente contemplativo è passibile di una rappresentazione totale di tendenza oleografica, un’autentica verità del paesaggio sarà più avvicinabile da parte di chi sta sulla soglia e pertanto si colloca un po’ dentro e un po’ fuori rispetto al mondo che maggiormente ha a che fare col paesaggio. E questo è spesso il caso di chi ha vissuto quel mondo simultaneamente in forme di esistenza diverse oppure divaricandosi progressivamente da esso.

Certo è solo in una commistione che incrina, ma non disinnesca del tutto la contemplazione panica, che si può arrivare a sentire la fatica e la sofferenza come condizioni stesse della bellezza, scongiurando ogni rischio oleografico. E io ho proprio vissuto il rapporto con la natura in forma intermedia, stando un po’ nei pressi della soglia, un po’ dentro e un po’ fuori.
Che volete, ad un certo punto la mia vita si è divaricata, facendo sì che conoscessi la natura sia a livello pragmatico, misurando quanta fatica costava al contadino/montanaro immergervisi quotidianamente, sia a livello artistico, rappresentandola con la mia scrittura.
E qui si inseriscono anche gli altri temi della domanda, i ricordi, le radici, la terra, il dolore e, mescolata al tutto, la religione, col correlato e ineludibile fardello di sensi di colpa. Io ho avuto un’educazione religiosa tetragona: a quella trasmessami da mia nonna paterna, che è stata per vent’anni presidente delle madri cristiane, si è sovrapposta quella delle suore della misericordia che mi sono trovato come insegnanti alla scuola elementare pubblica.
(S) Ci sembra che questo tuo sentire abbia trovato espressione privilegiata nella tua prima pubblicazione Al tràgol jért.
Sì, in quel primo libro, Al tràgol jért (una raccolta di liriche del 1988 n.d.r) trovano posto molti di questi aspetti: esso può essere considerato di forte contenuto antropologico, perché cerca di rappresentare tutta una cultura, che è poi quella che mi ha dato identità: lungo il suo percorso – il titolo in traduzione è “erta strada da strascino” – il mio “io” personale diventa “io collettivo” e infine apertamente un “noi evocato”, in un miscuglio di istanze individuali e complessive. Alla fine è comunque il tentativo stesso di scrittura poetica a tenere le fila e a portare da qualche parte: mentre lo si persegue non se ne ha piena contezza. Se ne accorgono meglio, dopo, i critici, che spesso col loro acume restituiscono all’autore molti significati nascosti, certi poi che neanche si erano immaginati.

(S) Nel merito dell’esperienza religiosa trasmessa in età scolare, era un pensare comune che “l’imparar no serviva” e la scuola era vissuta come tempo sottratto all’urgenza nel lavoro dei campi. Ma la domanda ora è: l’uso del dialetto, o lingua del fare, come si materializzava? Era diffusa la diffidenza per l’astrazione poetica, quasi una pratica di espianto attraverso il peso della parola.
In realtà la domanda ha piena motivazione nel fatto che il dialetto è linguaggio prettamente orale e che già portarlo in scrittura è una forma di snaturamento per il comune vivere e sentire. Inoltre, lo ripeto, era lingua, almeno nei miei luoghi, soprattutto pragmatico-referenziale, in una dura realtà e, per quanto uno scrittore cerchi di limitarvi soluzioni di peso intellettuale, non può non intriderla di movimenti mentali che non sono normali nell’uso comune.
La domanda porta poi ad aggiungere che altra pregiudiziale era quella che un tempo a scuola il fatto di essere parlanti dialettali più che altro lo si doveva patire: allora l’uso del dialetto costituiva un vero e proprio discrimine perché si riteneva impedisse un apprendimento corretto dell’italiano. Ma doveva più avanti accadere che anche famosi pedagogisti sostenessero che l’uso continuato di un doppio codice attiva meglio le sinapsi cerebrali, acuendo, assieme alla stessa intelligenza, la capacità di apprendere lingue diverse.
È peraltro da dire che dagli anni ’70 in poi si è riaccreditato il dialetto soprattutto perché si è capito che il mondo di cui era la voce si stava disfacendo e si sono a questo punto innescati nostalgici sensi di perdita, purtroppo spesso in direzione prevalentemente oleografica.
(L) E Zanzotto che pensava del dialetto?
All’inizio era sempre sembrato che propendesse per l’apprezzamento della lingua italiana come veicolo della poesia. Poi un giorno venni sorprendentemente a sapere all’interno di un incontro letterario all’Univesità Ca’ Foscari che aveva scritto ancor in tempi lontani che la lingua che avrebbe voluto sempre usare per la poesia era il dialetto, per la bellezza delle tronche, per la sonorità, ecc. Quindi ha rovesciato completamente quello che comunemente si pensava fosse la lingua che lui amava e privilegiava, anche se, essendo un grande sperimentatore, usava l’italiano con superlativa maestria nelle direzioni più impensate; nell’uso del dialetto tendeva invece generalmente a rimanere fedele al termine ancestrale, antico. Così in Filò, poi in Idioma e Mistieròi.
La sorpresa è stata data dagli Appunti e abbozzi per un’ecloga in dialetto sulla fine del dialetto, un testo non finito composto a più riprese fra il 1969 e il 1971, riemerso dalla sistemazione di alcune carte autografe quando il poeta era ancora in vita, agli inizi del 2000, a cura di Michele Bordin.
Il saggio di Michele Bordin viene ripreso da Elena Sbrojavacca, dottoressa di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nel suo illuminante lavoro intitolato Appunti e abbozzi per un’egloga in dialetto sulla fine del dialetto a filò: Andrea Zanzotto nel “posterno eterno”.
In quel testo il poeta arriva addirittura ad ammettere che la scoperta del dialetto gli ha fatto sentire qualcosa di fasullo in tutta la sua produzione in italiano.
Nel finale – se così si può dire per un testo incompleto – dell’ecloga, egli conclude che forse la sua vera lingua, quella che gli avrebbe concesso di «scriver bene», non è ancora mai nata. Ciò fa pensare ad un’evoluzione del suo pensiero di fronte alla scelta d’impiego poetico di lingua e dialetto: in questa analisi a posteriori quelle che erano potute apparire delle petizioni di principio assumono un’aura d’indistinto, quasi pulsioni di un continuo brancolamento/annaspamento all’attingere la “sua” lingua assoluta per la poesia.
Singolarissima è ad ogni modo la notazione che “ci sono poche parole tronche in italiano / poche consonanti alla fine”: il che fa pensare – è il caso di dire “ante litteram”, dato che questa proposizione è del 1971, che egli avesse già verificato che, come e forse più che per ogni codice poco usato o almeno non abusato poeticamente, la prosodia dialettale gli potesse offrire il destro per degli inusitati percorsi fonico-ritmici in cui i fenomeni di assonanza e dissonanza conferissero particolare vigore formale ai testi.
E tale notazione sulle tronche e di qui sulla carenza di consonanti alla fine delle parole porta il pensiero anche alle lingue anglosassoni e in particolare all’inglese che egli, sorprendentemente – e, alla luce di quanto detto, non solo complice la depressione – ha fatto codice eletto per gli haiku.

(L) Come sei venuto in contatto con lui? E cosa poi vi legò profondamente, la terra, l’heimat, le radici poetiche, culturali… che tipo di sintonia avevate tra voi?
Di Zanzotto la conoscenza agli inizi fu solo letteraria, sulla scia della sua fama: tramite i suoi scritti lo sentivo come un “nume” remoto e, timido per conto mio, maturai nei suoi confronti una annichilente soggezione. Una sera, alla fine di una sua conferenza, gli fui anche, mio malgrado, fuggevolmente presentato ma come pensai ed ebbi poi modo di verificare, in tanta ressa egli non se ne ricordò.
Il destino volle che lo conoscessi direttamente nel giugno del 1988 al premio letterario “Città di Thiene”, quindi assai più distante di quanto è il mio paese dal suo. Quattro mesi più tardi seppi per esteso cosa pensava del mio lavoro (di cui mi aveva peraltro fatto prima pervenire da una comune conoscente un giudizio lusinghiero) quando nella mia Vallata, appuntamento per me sconvolgente, mi presentò Al tràgol jért e, fatto viepiù inibitorio, di fronte a una grande folla. Un giorno mi disse al telefono, in piena ottica di poeta, “quel là l’é ’n libro” che val na vita”. E a varie riprese mi disse: “il tuo valore non può essere contestato”.
La mia soggezione, al di là di ogni introversione o timidezza, rimase ad ogni modo un grande limite nel rapporto con lui, come doveva essere per uno che l’aveva conosciuto attraverso i suoi scritti, talvolta tanto difficili ma proprio perché così profondi. Egli mi voleva amico ed io con forse sfrontata sincerità gli dicevo che mai lo sarei potuto essere, nel senso normale, “in disgrazia” del suo soverchiante livello culturale; mi replicava, affabilmente quanto inutilmente, che anch’io ero un poeta. Ma la vita mi attendeva al varco con la più tremenda delle prove e lui, con la sensibilità del grande poeta, fu vicino a me e a mia figlia Silvia come altri amici veri, più di altri amici meno veri: non potei più non riconoscerlo amico, mi riconobbi suo amico.
Ma devo dire che un rapporto più normalmente umano ebbe luogo a partire dal suo decadimento fisico, periodo in cui si caratterizzò anche da parte mia soprattutto affettivamente.
E ora, a più di cinque anni dalla sua scomparsa, quindi da una certa distanza prospettica, è inevitabile che sia quest’ultima fase ad essere più viva nel mio pensiero.
Su cosa mi legasse a lui importante fu certo l’appartenenza a un sostrato culturale simile; forse anche una sensibilità accesa, esiziale infine per l’esercizio del vivere… e poi, legato ai fattori precedenti, il culto per la poesia. È estremamente pertinente, nel caso, dire culto perché come la religione la poesia persegue, a suo modo, il raggiungimento di un assoluto.
Per quanto concerne la sua influenza sui miei testi penso che essa si sia estrinsecata più fortemente sulla seconda fase della mia produzione o non, ad ogni modo, sulla mia prima in dialetto, che era avvenuta, relativamente almeno alla mia prima pubblicazione, prima che egli pubblicasse Filò.
(S) A proposito di Nobel, che ne pensi del premio a Bob Dylan? Come sai, il mese scorso si è svolta a Treviso la terza edizione di CartaCarbone, alla quale era invitato anche Franco Buffoni. Manifestò, senza remore, un palese sconcerto per questa assegnazione. Nel merito, concesse al Nobel 2011 Tomas Tranströmer – di cui è traduttore – un tributo alla “lirica” casalinga svedese ma, sul presente letterario alzò il velo su De Lillo, Philip Roth e altri. Comunque – aggiunse – “mi preme qui ribadire il mio disaccordo, anche se mi riservo di capire”. In proposito, che considerazioni ti senti di sollevare?
Dico solo che posso capire dopo l’assegnazione del premio a Dario Fo, al cui riguardo penso quanto Montanelli ne scrisse anche in ironica comprensione dell’amico poeta Mario Luzi, il quale con Andrea Zanzotto era fra i più accreditati assegnatari italiani del riconoscimento.
Ritengo infatti che Bob Dylan, di cui mi dichiaro un follower della prima ora, segni rispetto all’attore italiano un passo in avanti, se non altro per l’influenza positiva che ha avuto, peraltro lungo la paritetica scia dell’inventiva musicale, su scala planetaria.
Non capisco comunque in base a quali criteri assegnano i Nobel letterari, perché a Fo avrebbero dovuto darlo eventualmente per la capacità di recitazione, affatto straordinaria… che contributo ha dato in campo letterario? Tolta la dissacrazione religiosa, mi sembra che delle sue opere non resti molto.
Se poi l’assegnazione del Nobel ha molto a che vedere con la geopolitica, c’erano appunto nel caso di Fo i nomi che ho citato io e in quello di Dylan quelli che hai citato tu, comprendendovi Philip Roth, a favore del quale uno dei più grandi critici tedeschi ha contestato alcuni anni or sono l’assegnazione del premio ad una sua connazionale.

(L) Comunque la si veda, Dylan è stato ed è un autore che con le sue opere ha contaminato la cultura internazionale, quindi anche la letteratura, pensiamo solo alla Beat Generation di Allen Ginsberg e Gregory Corso…
Certo, Dylan ha inciso, come dicevamo a livello internazionale, sulla sua e su generazioni antecedenti e seguenti. Ma questo, bisogna sempre tenerlo ben presente, col veicolo della melodia, fattore quanto mai adescante in sovrapposizione a quello della parola controcorrente. È facile poi che attorno a un successo che si fa luminoso si sedimentino comunità di ammiratori e intenti. E, di fatto, fra i testi del nostro menestrello principe e quelli degli scrittori che hai citato si colgono parecchie affinità. Solo che egli, pensando dall’origine a testi da adattare alla musica, non punta ad asciugarli, appunto in quanto non “parti” a sé stanti. Per questo l’«occhio letterario» vi può facilmente cogliere ridondanze e prolissità. Il che non è certo prima peculiarità della poesia, che mira a messaggi condensati e altamente formalizzati. Devo dire che possedevo già tre libri di testi di Dylan, ma per scrupolo ho di recente compulsato il computer per vedere quelli inerenti la sua produzione più recente. Ho constatato che c’è stato un avanzamento quanto a densità e formalizzazione ma comunque con passaggi che hanno più a che vedere col mestiere – se poi si può usare questo termine – della musica che con quello della poesia. Sinceramente fatico un po’ a inquadrare in prospettiva un’antologia in cui accanto a Ralph Waldo Emerson, Emily Dickinson, Walt Whitman, Hart Crane, Robert Frost, Wallace Stevens ecc. compaia, in tutta simpatia per lui, Bob Dylan.
(S) In scia al tuo rilievo su Dario Fo, ribadisco lo spontaneo disagio di Buffoni che si può sintetizzare così: “Come possiamo accettare questi premi Nobel assegnati dopo una settimana di trattative e dopo aver ignorato tanti nomi illustri, per esempio nel 1997 lo stesso Zanzotto – che resta comunque un Nobel assegnato per eccellenza – e il grande Mario Luzi”?
Per l’assegnazione a Dario Fo – lasciamo qui perdere i suoi controversi trascorsi politici – ricordo che Zanzotto pensava che il riconoscimento dovesse andare a Luzi e finì per assumere l’esito come una provocazione a tutta la categoria letteraria. Mi viene in mente al proposito un giocoso epigramma che in qualche occasione proferì: “Di Fo che me ne fo, Fo fu”.
Per quanto riguarda tempi e modi di assegnazione del premio svedese, non ho idea di come funzioni ma ho abbastanza cognizione di come funzionano certi altri. Quindi il mio stupore viene semmai dalla visibilità e quindi relativa criticabilità cui è esposto quel riconoscimento. Sempre sull’occasione dylaniana, pur sempre da “dylaniato” quale mi riconosco, mi vien di riprendere una dichiarazione fatta da Valerio Magrelli al proposito. Diceva il nostro ben riconosciuto poeta che l’assegnazione di un Nobel per la poesia dovrebbe avere innanzi tutto il senso di venire incontro a un’arte, se non sempre affatto schiva, comunque di nicchia, questo anche in considerazione del fatto che per la poesia anche la corresponsione economica ha un senso più spiccato che per altri campi di eccellenza, giacché questa “musa” non garantisce particolari compensi attraverso le vendite. Perché allora, si chiedeva Magrelli, conferire il premio a un cantautore? Il suo ambito di elezione è soprattutto quello della musica e proprio per questo solo in passaggi di grazia attinge i livelli della vera poesia e quindi a questa più che altro si avvicina… nella fattispecie poi a un cantautore mondialmente riconosciuto e in quanto tale coperto di appannaggi economici quando esistono esiti letterariamente ben migliori dei suoi e di autori magari in condizioni economiche ristrette.

(S) A proposito dell’intimità e spiritualità di Dylan… sono andato ad approfondire i suoi rapporti con la religione e mi sono trovato davanti a questo passo: “durante la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 Dylan si convertì al cristianesimo con grande fervore religioso. Partecipò anche a classi di lettura della Bibbia. Il pastore ricorda: “disse che voleva far entrare Cristo nella sua vita e quel giorno pregò e ricevette il Signore”. Dylan poi dichiarò di aver accettato Gesù Cristo nel ’78 nel suo cuore dopo una visione e sensazione durante le quali la stanza si era mossa: “C’era una presenza nella stanza e poteva essere solo Gesù Cristo”.
Quindi, di fronte a questo percorso di rivisitazione interiore attraverso le religioni istituzionali, che immagine ci possiamo fare di Bob Dylan?
Un’immagine certo un po’ contraddittoria. Inerentemente alla domanda, è da dire che la produzione di Dylan è stata spesso per vari aspetti, sia di segno positivo che negativo, sostanziata dalla formazione religiosa. Certe sue composizioni sono impregnate di senso biblico. Non dimentichiamo che era di religione ebraica e che come tutti i bambini ebrei da piccolo aveva dovuto macerarsi sulla Bibbia. Ma anche in altri ambiti, non solo in quello religioso, la sua traiettoria di pensiero ha fatto registrare dei passaggi contraddittori.
Ad un certo punto cercò di scrollarsi di dosso la veste assoluta di cantautore di protesta, suscitando molteplici rimostranze, fra le quali quelle dell’amica Joan Baez. E arrivò poi anche a calzare contenuti e stilemi della musica country, filone ritenuto dalla maggior parte dei folksingers statunitensi affatto conservatore. In tutto ciò ci fu certo da parte sua l’insofferenza a essere ingabbiato in un cliché che sentiva tarpante rispetto alla sua complessiva ispirazione.
Tornando alla religione, anch’io mi sono stupito del passaggio al cristianesimo. Ma non ho ragioni – parlo anche da supporter – per mettere in dubbio la sua buonafede. Certo si espose a più di un frizzo, il più automatico dei quali fu di vedersi scrivere dopo la radente “With God on our side”, excursus su tutte le guerre statunitensi condotte sotto l’egida divina, “adesso anche lui ha Dio dalla sua parte”.
Ma nel suo tragitto, generalmente eccellente per risultati scrittorio-musicali, non mi sarei aspettato una delle ultime sortite con le interpretazioni di brani di grandi cantanti “normali” americani. Vorrà pure essere ricordato come una “voice of America” ma avrebbe potuto evitare questo ulteriore viraggio, forse più di altri sorprendente.
(L) Lasciando Bob Dylan al suo destino di “Nobel errante”, vorrei tornare al tuo rapporto con Zanzotto – per chiudere questo capitolo – e chiederti che ne pensi del fatto che lui ti definì a più riprese suo “erede”, come ha poi fatto qualche illustre critico letterario…
Purtroppo è vero, l’ha detto in un’intervista il giorno seguente la scomparsa di Luigi Meneghello. Ricordo di aver provato, di primo acchito, «contentezza e gratitudine», ma di essere stato subito dopo assalito dal peso della responsabilità e dal timore dell’inadeguatezza. Gli dissi a più riprese che mi sopravvalutava e mi sovraesponeva. La prima volta Zanzotto mi rispose: “Varda, par quant che me varde atorno… (guarda, per quanto mi guardi attorno…)”. Quando l’ha dichiarato una seconda volta me ne sono nuovamente lamentato e lui ha replicato: “Ma se ò da parlar ben, òe da parlar mal?” Poi, la terza volta, è sbottato: «Ma insoma, sarò paron de dir quel che pense!”».
Certo questo mi ha messo in grave imbarazzo: mi sentivo come un pesce a boccheggiare sulla battigia… anche perché non ho la produzione vasta e profonda di Zanzotto in ambito poetico e men che meno in ambito critico, il tutto correlato a una intelligenza e a una cultura stratosferiche. Egli era in grado di parlare, lasciando stare il suo campo precipuo di letterato, coi pensatori come un filosofo, con gli scienziati come un uomo di scienza, con i religiosi come un teologo.
Il mio disagio si è un po’ ridotto dopo il pronunciamento, oltre che di altri rinomati critici, del grande Cesare Segre. Da pesce esposto sulla battigia ho un po’ sentito di poter avvoltolarmi nella sabbia…

(S) A questo proposito, i lettori di “poesia” si immedesimano nel culto del genius loci. Cercano di avvicinare il dove una parola diventa poesia e il come viene colta da chi la trapassa, la filtra e la fa vivere. Insomma, in assenza fisica degli Autori, evocano il risuono dei luoghi. Quali sintonie si innescano tra paesaggio e poesia?
Partendo dalla coda della tua domanda, per me è stata nella fattispecie elezione di nascita. I luoghi in cui sono nato, quasi per contrappasso assai poveri, sono paesaggisticamente affatto suggestivi.
Io certo me ne sono reso conto tardi, dato che da piccoli non si riflette tanto sulla natura delle cose, anzi le si vivono, per così dire, come “naturali”. È solo più avanti che ci si rende conto appieno di certe peculiarità. Una volta mi ha detto Marco Munaro: “dalle vostre parti ci deve essere qualcosa nel paesaggio che ispira particolarmente”. E un giorno mi capitò di incontrare lungo la stradina costruita lungo il lago con i fondi europei un uomo di passaggio per ragioni di lavoro che contemplava estasiato il paesaggio nel fulgore meridiano della matura primavera. Egli mi guardò e mi disse: – Ma in che posto straordinario vivete voi?
Io gli risposi che, sì, lo sapevo ma che avevo realizzato molto tardi di aver avuto il privilegio di vivere infanzia e giovinezza in una valle che aveva qualcosa di edenico. E ancora solo più avanti ci si accorge che il paesaggio parla dentro di noi e in quel dentro c’è anche l’uomo “etnologico” con la sua eredità di cultura “indigena”. Si finisce allora per sentirsi proprio dei medium di tutto questo.
(S) In effetti, proprio nell’occasione del convegno di CartaCarbone, un relatore, Paolo Gobbi, sosteneva che i Colli Euganei rappresentano il cuore pulsante del Veneto. Tant’è che Zanzotto, ferito dallo “sterminio dei campi”, aveva espresso il desiderio di trasferirsi ad Arquà Petrarca, c’è del vero in questo?
Sì l’aveva detto, per aggiungere presto che i luoghi dove aveva cespite la sua ispirazione erano quelli che andavano da Pieve di Soligo, al Quartier del Piave, alla Vallata delle Prealpi Trevigiane. Già Asolo era per lui fuori campo. E infatti, pur mugugnando per il progressivo scempio del paesaggio – per lui un po’ una tortura – finì per non trasferirsi altrove.
(L) Insomma Luciano, noi continuiamo a pensare che sei un grande poeta (si può dire o protesti?) umile e schivo. Ma, entrando invece nel vivo della tua produzione e creatività letteraria, vorrei chiederti qualcosa che si riferisce alla nascita e allo sviluppo della tua poesia…
Mah… che vuoi… sono un po’ pigro. E per di più in passato la scrittura mi faceva paura… e in certa misura mi fa paura anche oggi. Per dirti… una volta scrivevo a matita, in fogli sparsi. Avevo con quella della pagina bianca, la paura del segno dell’inchiostro che mi dava un senso di irreversibilità. Comunque scrivevo solo quando qualcosa mi entrava nella mente per restarci, diventando talvolta quasi un ganglio nevralgico, un pensiero che, divenuto dominante, era capace di comprimere gli altri. Così è stato per la cultura di questi luoghi che ho cercato di salvare, così per l’emigrazione – mentre mio nonno era in America un mio bisnonno era in Russia – così è stato per la Resistenza. Tutto in fondo – a quest’età lo posso dire con cognizione di causa – è legato ad un percorso che ha avuto a che fare con la mia biografia intrecciata con quella di famiglia. Non ho mai scritto libri d’occasione. L’ultimo libro, in attesa di pubblicazione, è poi sulla tragedia di mia figlia, un libro inevitabilmente angosciato e angosciante.

(S) Ricontestualizzando gli esordi della conversazione e marcando le traumatiche scelte individuali nella temperie politica di fine guerra, un recente referente filmico (“lettere da Berlino” su testo di Hans Fallada – pseudonimo di Rudolf Ditzen) ben rappresenta il clima che hai evocato. La reazione umana dei genitori per la perdita dell’unico figlio “prestato” ai fasti bellici del nazismo, rimuove il dolore soggettivo (il padre riaffigura da un pezzo di legno la testa del figlio) e converte l’attenzione collettiva in centinaia di avvisi clandestini. Padre e madre pagheranno con la decapitazione la sfida pubblica al regime. La sublimazione del dolore individuale è una così potente leva?
Per quel che mi riguarda, penso proprio che questo sentimento poco auspicabile, abbia avuto per me un’incidenza prevalente in relazione a vari accidenti dell’esistenza.
Entro un’abulica inerzia la poesia per me ha sempre avuto a che fare, come già detto, con un pensiero che si faceva dominante, fosse esso innescato dal senso del bello o dall’inclemenza del tragico. Nel secondo caso la scrittura è divenuta per me in fondo una terapia tesa a medicare gli effetti dell’incontro/scontro tra degli eccessi o, ammettiamolo pure, tra delle storture interiori e i mali esistenziali. Certo è una terapia che può portare linimento solo attraverso dei travisamenti, che possono addensare anche aure di favola ma non eliminare il nocciolo innescante, appunto la durezza e l’acerbità del tragico, cui tu alludi nella domanda.
Il dolore è qualcosa che generalmente si accetta, nella vita. L’emigrazione, anche senza speranza di ritorno, era in fondo una cosa abbastanza comune e c’è stata per me certamente una redenzione di quel male della storia familiare attraverso il viaggio letterario americano.
Il tragico ha però la forza dell’inaccettabilità nella morte di un figlio. Probabilmente nella vita non ci può essere sofferenza più grande di quella, come senza proporzioni è la crisi che ne consegue: l’ordine dell’universo si frantuma, il senso dell’esistenza si perde in un vortice confuso di rabbia, pena ed ansietà. Dal momento che la missione parentale è in qualche modo fallita, si cade poi spesso in preda a sensi di colpa per ciò che si è fatto o non si è fatto. E se ogni esperienza è personale e particolare nelle circostanze, è sempre spaventosa nella sua panica invasività, al punto da essere sentita incredibile pur se la si sta vivendo.
“Il più grande delitto è sopravvivere alla morte di un figlio” ha scritto Luigi Pintor, volendo significare come un genitore possa sentire, in linea con quanto precedentemente significato, l’estremo senso di colpa: quello di aver dato la vita a un figlio perché gli sia presto sottratta. E’ sempre Luigi Pintor a dire: “La condizione di un genitore che sopravvive è piena di vergogna” e “si fanno odiosi i gesti quotidiani, diventa abusivo respirare e camminare”.
(L) Sì, a te il destino ha anche riservato quello che da tutti viene considerato il male più grande…
Un male forse senza colpa ma che non si spegne mai come se, per un’imposizione irrazionale, non potesse avere assoluzione.
Anche perché a datare dalla malattia di mia figlia ogni possibile ispirazione veniva immediatamente sopraffatta dal pensiero di quel disastro. Il tentativo poetico, per quanto almeno, come già detto, a me succede, richiede la concentrazione massima e questa fa sempre emergere il pensiero dominante, che per me era quello della figlia sfortunata. E non potevo certo allora ridurla, malata e poi, purtroppo, perduta, a soggetto letterario.
Pertanto per molto tempo mi è stato solo possibile rivedere, più o meno meccanicamente, gli scritti anteriormente sedimentati, un po’ come il malato cerca di uscire dalla cognizione della propria malattia tramite l’esercizio meccanico delle parole incrociate. Questa situazione, che ha a che fare col problema dell’ineffabile – ma non certo, come altrove, di natura idillica – mi inibiva la volontà di scrittura, per cui verso di essa avevo a un certo punto maturato una forma d’odio.
Ma è anche vero che con quel pensiero a distanza di anni, seppur per episodi e lacerti, mi sono misurato, come se una evenienza così innaturale comportasse per me e per tutti quelli che l’hanno vissuta un dovere di testimonianza.
A tutt’oggi, però, quando mi risolvo a riprendere contatto con i testi scaturiti da quel pensiero dominante, riesco per un periodo a lavorarci su ma appena li lascio per un po’ da parte, mi prende paura e fin repulsione a rileggerli, rimandando generalmente ad altri tempi. Va ad ogni modo detto che quel truogolo ha sedimentato una raccolta che, pur se ancora di certa ridondanza per riprese da ossessioni, è assai più consistente delle precedenti. Certo qui, per quanto addomesticato dall’eventuale bellezza delle forme, il tragico non potrà attingere aspetti da favola. Ma chissà che il tutto non possa convogliare, se non certo il profumo, l’acre agrore che consenta di definirlo poesia; anche perché non so se riuscirò mai a rivedere quei testi col conveniente distacco. Se il tentativo di poesia è sempre una scommessa, in me è, nella fattispecie, più forte la paura di perderla.
(L) E il tuo modo di scrivere è cambiato nel corso degli anni?
(Ridendo) E’ cambiato nel senso che… ora scrivo a penna, non più a matita, anche se comunque sempre su foglietti sparsi. E poi, devo ribadirtelo, una forma di un po’ abulica inerzia c’è sempre stata ed ha spesso determinato una mia “nolontà” rispetto allo scrivere, che con l’età è stata inevitabilmente acuita da un certo senso di inanità.
(L) Direi che questa lunga conversazione, che a tratti si è trasformata in un’intima e dolorosa confessione – comunque sorretta da una lucidità di pensiero ammirevole, nel solco di un’onestà intellettuale davvero esemplare –, può chiudersi qui, non prima comunque di averti chiesto a quali lavori ti senti più legato.
(Ridendo) Non saprei, non sono preparato a rispondere. All’impronta direi che il libro che mi è ora intimamente più vicino e che quindi più sento appartenermi è quello sulla mia figlia perduta, che deve ancora uscire e che dovrebbe avere per titolo Ricordarsi di lei. Cito anche In silenzioso affiorare, che, pubblicato nel 2015, è pure di tenore affettivo-familiare, con largo spazio, prima dell’aggressione che sarebbe sfociata in tragedia, a una rappresentazione idillica dell’amore.

Revine Lago, marzo 2017
Nota
Abbiamo riportato e trascritto questa conversazione col poeta Luciano Cecchinel cercando di cogliere la sua essenzialità e profondità umana ed artistica, senza indagare a livello critico le sue opere, perché presenteremo in questo reportage parecchi commenti critici che lo fanno in maniera molto autorevole.
A noi interessava trascorrere qualche ora con un poeta che sta sulla scena letteraria da molto tempo, in silenzio e in compagnia solo del nutrimento poetico che scorre dentro e attorno a lui, denso e leggero.
Diego Lorenzi e Giuseppe Stefanel
©riproduzione riservata

Nota biobibliografica
Luciano Cecchinel (Revine-Lago, 1947), si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Padova nel 1971 ed ha insegnato a lungo materie letterarie nella scuola media.
Dopo un’esperienza in campo amministrativo locale, ha partecipato all’attività di gruppi operanti ai fini dell’organizzazione di base del territorio nella prospettiva della salvaguardia del tessuto socioeconomico e culturale. Si è impegnato, in particolare, nella costituzione di cooperative nel settore agricolo, maturando “in situazione” interessi per la cultura popolare e, in particolare, per quella contadina.
La sua attività poetica è rimasta volutamente incognita fino alla pubblicazione della raccolta di poesie in dialetto alto trevigiano Al tràgol jért (Pederobba, I.S.Co. 1988), con testi elaborati a partire dalla seconda metà del decennio precedente; ha fatto seguito Senċ (Conegliano, El levante por el poniente 1990, con una tempera di Giani Sartor). Del 1997 è la plaquette Testamenti (Milano, en plein, con un disegno di Vittorio Schweiger). Nel 1999 viene pubblicata con la postfazione di Andrea Zanzotto – poeta col quale Cecchinel ha stretto, nel tempo, un lungo sodalizio – una riedizione riveduta e ampliata della prima opera Al tràgol jért (Milano, Scheiwiller).
All’inizio del 1998 la sua esistenza ha subito una irrimarginabile cesura con il manifestarsi di una rara malattia nella figlia primogenita, deceduta dopo varie e pesanti terapie il 16 aprile del 2001.
Più avanti sono venute, dopo la serie di pubblicazioni nel dialetto del suo paese, alcune opere parzialmente o totalmente in lingua italiana, che erano rimaste per anni accantonate.
Lungo la traccia (Torino, Einaudi 2005) è il resoconto del suo primo viaggio/pellegrinaggio negli Stati Uniti d’America alla scoperta dei luoghi d’emigrazione dei nonni e d’infanzia della madre Annie, nata e cresciuta a Cambridge Ohio.
Perché ancora / Pourquoi encore (Vittorio Veneto, Istituto per la Storia della Resistenza 2005, con note di Martin Rueff e Claude Mouchard e traduzione dello stesso Rueff) e Le voci di Bardiaga (Rovigo, Il Ponte del Sale 2008) riprendono i drammi legati alla lotta di liberazione, nella quale il padre, “partigiano e democristiano”, ha militato come vicecommissario di brigata e comandante di battaglione.
Ancora totalmente in dialetto la plaquette Parlar cròt (Venezia, Tipografia L’Artigiana 2009, con un’incisione di Luigi Marcon e note di Alessandro Scarsella e Matteo Vercesi) e il volume Sanjut de stran (Venezia, Marsilio 2011, con un’ampia e analitica prefazione di Cesare Segre).
Nel 2012, a seguito di un convegno organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e tenutosi al Teatro Candiani di Mestre il 24 settembre 2009, è stata pubblicata la raccolta di saggi La parola scoscesa. Poesia e paesaggi di Luciano Cecchinel (Venezia, Marsilio 2012), monografia curata da Alessandro Scarsella, contenente tre testimonianze di Mario Rigoni Stern, Massimo Cacciari e Andrea Zanzotto.
Sono infine usciti In silenzioso affiorare (Cornuda, Tipoteca Italiana 2015, con prefazione di Silvio Ramat e sei acquerelli di Danila Casagrande) e Da un tempo di profumi e gelo (Falloppio, LietoColle 2016, con postfazione di Rolando Damiani).
Un’altra monografia dal titolo Luciano Cecchinel – Poesia. Ecologia. Resistenza è uscita nel 2016 a cura di Paolo Steffan (Osimo – AN -, Arcipelago Itaca).

Completiamo la lunga conversazione con il poeta Luciano Cecchinel, preceduta dai due autorevoli commenti critici, proponendovi una selezione di poesie tratte dalle sue opere e una selezione di stralci da recensioni
SELEZIONE STRALCI DA RECENSIONI
Nota
La foto di copertina è di Paolo Steffan
© finnegans. Tutti i diritti riservati

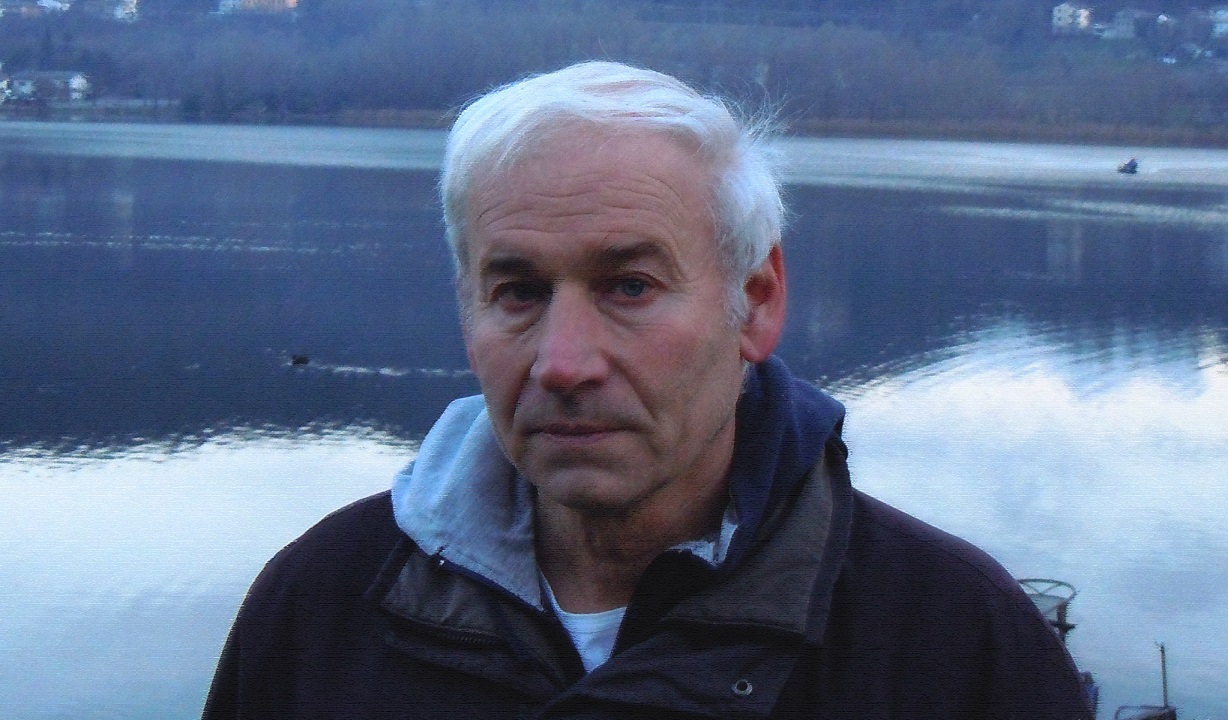


Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.