
Dietro i reticolati, dovunque si voltasse, il paesaggio arido e deprimente del Texas si estendeva per chilometri e chilometri: anzi, come dicevano loro, i vincitori, per miglia e miglia. Una condizione purgatoriale, perfetta per fare i conti con le proprie colpe, col proprio destino. L’amarezza della disfatta, la vergogna della prigionia, il dubbio di aver sbagliato tutto: Giuseppe Berto nel 1943 non aveva ancora compiuto trent’anni, e forse temeva che il meglio fosse alle spalle. Ora bisognava fare i conti con le macerie della propria giovinezza, un tutt’uno con quelle della nazione. Eppure lì, in mezzo al nulla, magari solo per sfuggire alla disperazione e alla noia, Berto scoprì la propria vocazione di scrittore: attraverso Hemingway, Steinbeck (il campo di prigionia di Hereford era vicino alla “gialla Amarillo” di Furore), Saroyan e Wiechert, dimentica d’Annunzio per trovare un modo nuovo per dire le cose. Scrive qualche racconto per la rivista redatta nel campo e inizia un romanzo breve, a cui dà il titolo provocatorio, Le opere di Dio. Poi, un giorno, alcuni prigionieri appena arrivati, nelle baracche attigue, parlano di un tremendo bombardamento sulla città di Treviso. Notizie smozzicate, incomplete, ma quanto basta perché Berto si metta a scrivere quello che resta il suo capolavoro: Il cielo è rosso.
Vicino a Treviso, a Mogliano Veneto, Giuseppe Berto era nato il 27 dicembre del 1914. A Treviso aveva studiato, senza brillare. Un po’ ribelle, un po’ velleitario, aveva aderito al fascismo, in cui vedeva un’opportunità di riscatto per sé e per l’Italia, e aveva inseguito la gloria militare in Africa orientale, nel ’35, e in Libia poi, con i battaglioni delle camicie nere, nel ‘42. La sconfitta di El Alamein costrinse le truppe italiane nel cul de sac tunisino, facile preda per gli angloamericani: fine delle speranze di gloria. Berto racconterà quei giorni nel libro Guerra in camicia nera, pubblicato nel 1955, scritto “per far sì che la guerra sia veramente perdonata”, dove l’ironia non sempre basta a stemperare lo sconforto per l’impreparazione militare e l’amarezza per l’inutile sacrificio dei singoli.

Protagonista del primo romanzo scritto nel campo di Hereford, Le opere di Dio, è una famiglia contadina che, a causa del ripiegamento del fronte, è costretta a abbandonare la propria casa e animali fino a perdere ogni cosa. Il titolo è tratto da un episodio del Vangelo in cui si parla di un cieco guarito; è Cristo stesso a dire che quella cecità era necessaria affinché fossero manifestate le opere di Dio. Ora, si chiede Berto, se il miracolo del cieco serviva per dimostrare la propria divinità, che dire di tutti i ciechi che non hanno l’opportunità di incontrare Cristo? Le opere di Dio è un titolo blasfemo: ma per Berto, anche la bestemmia esprime, sia pure in un modo aberrante, un sentimento religioso. “Berto non crede alla provvidenza – è lo stesso autore a dirlo –, il male lo vede in tutta la sua crudezza e afferma ironicamente: ecco le opere di Dio, la guerra che travolge i ciechi nati, ossia gli incolpevoli contadini e adolescenti… La religione di Berto si ferma al tragico, e anch’esso misterioso grido di Gesù sulla croce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Misterioso fino a un certo punto: nasce infatti da un immenso senso di colpa: non s’era forse Gesù caricato di tutti i peccati degli uomini? Un immenso senso di colpa si nasconde pure sotto il titolo Le opere di Dio, una bestemmia contro se stessi”.
Questo primo periodo, che Berto definì “della disperazione e dell’inconsapevole approccio neorealistico”, culmina con quel capolavoro di grazia e crudeltà che è Il cielo è rosso, il cui titolo originale era La perduta gente, frutto di una sensibilità acuita in modo “quasi morboso” perché “non c’è quanto star chiusi in una prigione che aiuti a sentire il mondo”. Mette in scena un dramma i cui protagonisti sono adolescenti che, nascosti nella zona proibita della città distrutta, lottano contro la disperazione che nasce dalla coscienza di un “male universale” costruendo una piccola comunità senza adulti, in cui ripongono le loro speranze per un futuro diverso. Ma il destino di Daniele, Giulia, Tullio e Carla è tragico: Tullio, il più spavaldo del gruppo, verrà ucciso dai carabinieri, Giulia morirà di tisi e Carla – uno dei più bei ritratti femminili della letteratura italiana del dopoguerra – continuerà a prostituirsi, mentre Daniele si suiciderà, incapace di sostenere il confronto con un male avvertito come inestirpabile. Il suo suicidio viene paragonato – anche qui con intento provocatorio – al sacrificio di Cristo. Daniele, sorta di doppio dell’autore, è figlio di quella borghesia responsabile del fascismo e della guerra, ed era giusto – dice Berto – che sparisse nel disastro. Ma Daniele è anche Berto, e “chi creava quel personaggio e in lui si identificava, era un povero cristo dentro un recinto di filo spinato, tanto dolorante da sentirsi responsabile d’un male che per molti versi sembrava addirittura trascendere la capacità umana di fare del male, e tanto superbo da volersi assumere i peccati degli altri e di voler finire, se non su una croce, almeno sotto un treno”.

Tornato dalla prigionia, Berto riuscirà a trovare un editore grazie a Giovanni Comisso. “Caro Leo – scrive Comisso a Longanesi –, una lieta sorpresa ho trovato qui vicino a Mogliano Veneto, un giovane scrittore che non ha mai pubblicato niente… Tu vedessi nel romanzo certi dialoghi di ragazzette che si avviano a quella che sarà la loro vita di prostitute che sorprendente umanità hanno”. Longanesi lo pubblicò gli ultimi giorni del ‘46, intervenendo con alcuni tagli e con un nuovo titolo, Il cielo è rosso, che proveniva dai Vangeli: “un titolo bellissimo e astuto, che magari aveva poco a che fare col testo, ma restava immediatamente impresso in chi lo vedeva”, commentò Berto.
Il romanzo ebbe un buon successo, e insieme al libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, rappresentò una delle novità più interessanti per la letteratura italiana appena uscita dalla guerra. Leopoldo Trieste (futuro sceneggiatore del Cielo è rosso per la regia di Claudio Gora nel 1950), entusiasta del libro, inviterà Berto a Roma a lavorare nel cinema. Ma le cose non andranno secondo le attese, e il periodo romano sarà contrassegnato da amarezze e delusioni. Il primo segnale è la scarsa attenzione che riceve la pubblicazione delle Opere di Dio (1948), accusato di essere una brutta copia di Hemingway. Berto, allora, affida le proprie speranze di successo al romanzo Il brigante. Pubblicato da Einaudi nel 1951, venne sbrigativamente liquidato da una stroncatura malevola di Emilio Cecchi che ne condizionò la ricezione: un peccato, perché nonostante qualche ingenuità, il romanzo non è privo di interesse; narra la storia di Michele Rende, ribelle istintivo all’ingiustizia sociale, una sorta di Tom Joad trasportato sui monti della Calabria. Tutta la vicenda è vista attraverso gli occhi di un adolescente, Nino, affascinato dal “brigante”, che rispetto ai ragazzi dei romanzi precedenti rappresenta una speranza e una via di salvezza.

Il brigante interpreta il tema della giustizia e della questione meridionale in modo più lirico che (neo)realistico: basti confrontare il libro di Berto con quello di Jovine, uscito appena un anno prima, Le terre del Sacramento, per valutare la differenza. Non per niente Berto, più che neorealista, si definiva neoromantico, ma questo non significa che il libro sia insincero nel denunciare con forza la violenza della “legge”: il capitolo in cui Michele Rende guida i contadini a occupare le terre lasciate incolte dai latifondisti, scontrandosi con i carabinieri, offre un racconto teso e drammatico che raggiunge toni epici e commossi. Oggi però, forse, colpiscono di più certi dettagli allora non considerati: alla stregua di un grande pittore veneto come Jacopo da Bassano, Berto sa raccontare con sensibilità e partecipazione il mondo animale, sia che si tratti del cane Said o dell’asino che accompagna quotidianamente Nino al piccolo podere coltivato con ostinazione: pagine nascoste tra le pieghe del romanzo, a tratti intensamente struggenti, come se tra il mondo adolescenziale e il mondo animale si stabilisse una comunicazione più intima e vera.
Nel 1974, quando Il brigante verrà ripubblicato, Berto nell’introduzione individuerà tre elementi che caratterizzavano il neorealismo: il primo è la fede nel socialismo, “al quale non pochi tra noi erano pervenuti, senza grossi traumi, direttamente dal fascismo, il quale certe sue tendenze socialiste, non si capisce bene come, era riuscito a tenerle in vita nonostante tutto”. Il secondo elemento stava in una rabbiosa rivolta contro la viltà della cultura del tempo e contro tutte le forme di menzogna. Il terzo, che Berto definisce “strabiliante elemento”, non senza caustica autoironia, fu “una specie di megalomania di tipo messianico… la convinzione d’essere in possesso di verità assolute e di avere la missione di divulgarle”. Tutto questo portava lo scrittore a “aggredire la realtà, specie quella realtà di miseria, dolore, ingiustizia, alla quale il fascismo aveva cercato di non farci pensare affatto”. Ma la stagione neorealista, proprio mentre scriveva il libro, giungeva al termine: “la favola era finita”. Nelle coscienze di alcuni – e nell’inconscio di molti, aggiunge Berto – nasceva il sospetto che “neppure dal marxismo l’uomo possa aspettarsi felicità e giustizia, la supposizione angosciante che tra marxismo e composizione psicologica umana ci sia una incompatibilità che costringe il potere alla violenza e alla crudeltà”.

La constatazione del fallimento di un’epoca insieme al timore di un fallimento personale, porta Berto a una crisi profonda. A ciò, si aggiungano le mortificazioni e le frustrazioni che provenivano dagli ambienti letterari (frequenti le polemiche, specie con Moravia, considerato un vero e proprio “capobastone”) e cinematografari romani (con cui collaborava di mal grado e con risultati discutibili): l’esito sarà la depressione e una sorta di blocco narrativo, da cui uscirà solo nel 1964, condensando anni di psicanalisi nel romanzo Il male oscuro, vincitore del Campiello e del Viareggio, che riporterà a Berto il successo. Eppure ha ragione Luca Doninelli, credo, quando scrive che Il male oscuro, questa “Bibbia dei perturbati, degli insonni, consumatori di ansiolitici, convincente definizione dell’uomo moderno”, nonostante le sue apparenze sperimentali rappresenta un passo indietro rispetto la precedente produzione. “Il mondo intellettuale e la cultura accademica dell’Italia, le sue chiusure ideologiche e il suo eterno petrarchismo, uniti al carattere impaziente del Nostro, non seppero offrire a Berto gli strumenti culturali veri per fronteggiare questa nuova avventura. Solo un po’ di psicanalisi da accattonaggio, niente di più”.

Per chiudere, vale la pena, tralasciando altri testi, soffermarsi sull’ultima opera di Berto, anche questa controversa: La gloria (1978, Mondadori, uscita postuma). La storia di Cristo è raccontata da Giuda Iscariota, simbolo universale del tradimento e del senso di colpa, con cui Berto sembra identificarsi. Ma Giuda è anche – questa la tesi centrale del romanzo – strumento necessario e indispensabile per il trionfo di Cristo, a cui quindi partecipa a pieno titolo: la gloria di Cristo presuppone l’ignominia di Giuda, senza la colpa di Giuda non si avrebbe la gloria. Infatti, come racconta Giuda, è Cristo stesso a eleggerlo al ruolo del grande traditore.
Il romanzo chiude il cerchio aperto con la sua prima prova: “Riappare l’antico rovello ‘religioso’, quel confronto all’orlo del blasfemo che già si era rivelato ai tempi lontani, originari, delle Opere di Dio”, scrive Andrea Zanzotto, sottolineando questo bisogno di un rapporto con l’orizzonte metafisico, frequente negli autori veneti, “e Berto è uno scrittore veneto ‘spaccato’, quasi fradiciamente veneto. C’è una strana fratellanza, un humus che caratterizza la letteratura dei veneti… In un quadro che vede grandi nomi, quali appunto Comisso, Piovene, Parise, Buzzati, autori che hanno mirabilmente sentito e rappresentato lo spirito particolarissimo delle loro province e città d’origine, offrendoci le molte sfaccettature positive e negative dell’“essere veneti”, Berto si può iscrivere a buon diritto e con ottime carte”.

A Berto – come a Giuda, d’altra parte – sembra essere sfuggita definitivamente la gloria: di lui si è parlato poco, l’occasione del centenario, oramai quasi dieci anni fa, sembra più un’occasione mancata. Presso la Neri Pozza, sono usciti in questi anni Il male oscuro, Anonimo veneziano, La cosa buffa, Il brigante, Il cielo è rosso, La gloria e Guerra in camicia nera. Ma più che la serenità, per poter collocare lo scrittore nella storia della letteratura, sembra mancare l’interesse: forse la nostra storia letteraria fatica a fare i conti con gli irregolari della scrittura e se Berto ieri ha scontato l’ostracismo della società letteraria, oggi ne sconta l’indifferenza.
***

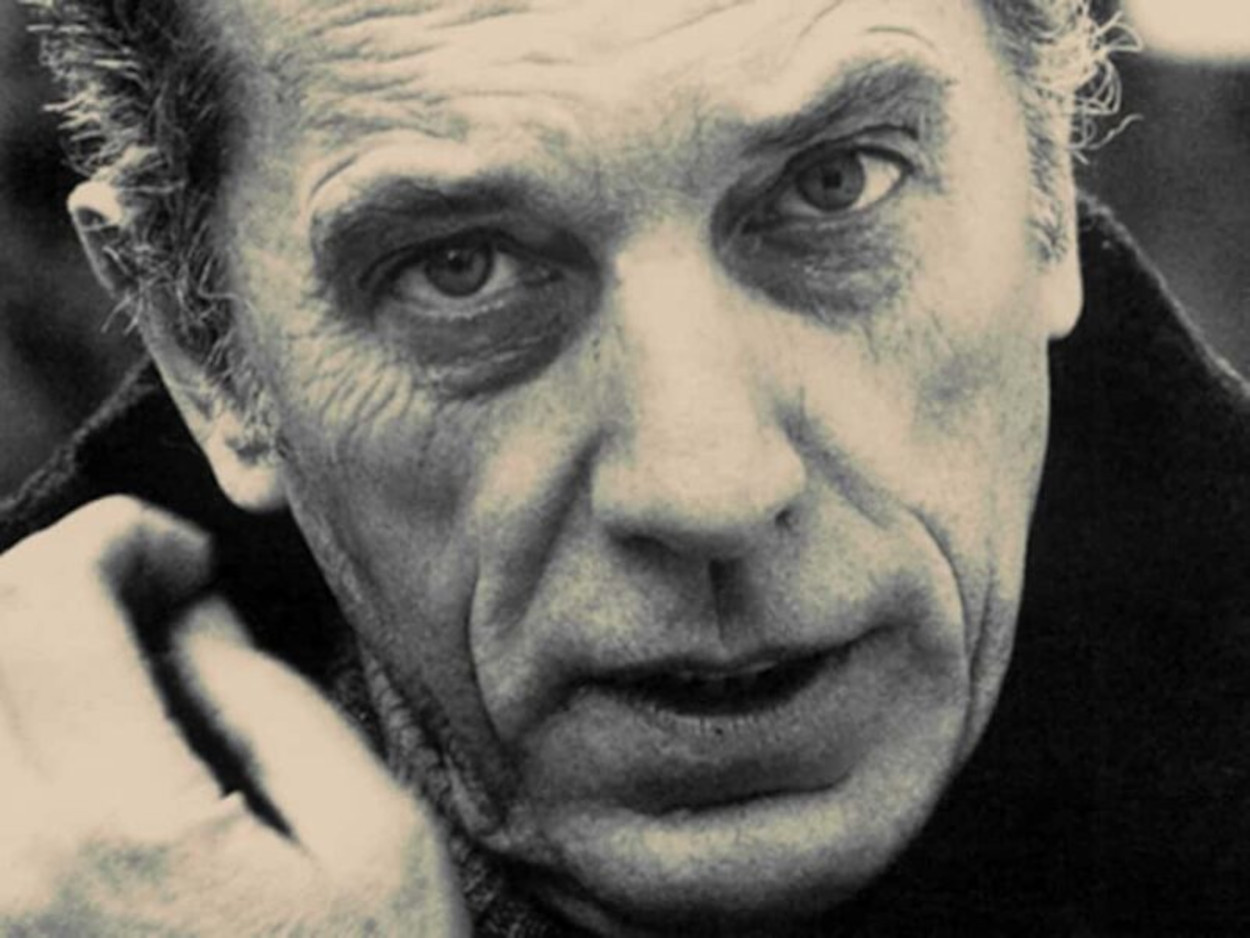

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.